La pluralità dei significati di un testo parlato o scritto non è necessariamente un male: i rebus ci insegnano a vederne, invece, il fascino e la ricchezza
.
Intervista a cura di Alessandra Ricciardi pubblicata sul numero di luglio 2021 della rivista [1]Cubo [1] dell’Università degli Studi di Bologna – Le altre interviste, recensioni e commenti sul libro L’ora desiata vola sono raggiungibili dalla pagina web a esso dedicata [2]
.
.
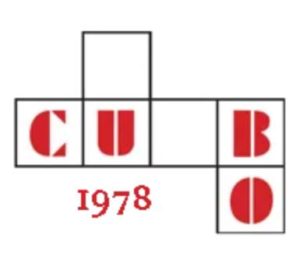 [3]«Anche la vita è un rebus: la verità non è mai quella che appare». Pietro Ichino, giuslavorista, considerato il padre del Jobs act, ex senatore del Pd, si è concesso, complice l’epidemia, un lavoro per lui inusuale: un libro sull’enigmistica, da poco uscito per Bompiani, L’ora desiata vola – guida al mondo dei rebus per solutori (ancora) poco abili.
[3]«Anche la vita è un rebus: la verità non è mai quella che appare». Pietro Ichino, giuslavorista, considerato il padre del Jobs act, ex senatore del Pd, si è concesso, complice l’epidemia, un lavoro per lui inusuale: un libro sull’enigmistica, da poco uscito per Bompiani, L’ora desiata vola – guida al mondo dei rebus per solutori (ancora) poco abili.
Una vita ricca di curiosità, studio e impegno, quella di Ichino, che per il suo percorso riformista sui temi del mercato del lavoro finirà anche nel mirino delle Nuove BR. In questa intervista racconta delle sue passioni, dal diritto del lavoro alla politica. E delle sue delusioni.
Professor Ichino, perché ha scritto un libro in materia di enigmistica?
R. Non mi sarei mai permesso di farlo, non avendone alcuna competenza. Ma c’era il lockdown, non si poteva vedere nessuno né muoversi da casa per mesi; e avevo uno scartafaccio sul quale avevo incollato i rebus più belli da quando avevo vent’anni. Ho pensato che quello fosse il momento, o mai più, di pubblicare una sorta di antologia, cercando di spiegare il perché della scelta di quei rebus. Poi, presentandoli, mi sono accorto che per renderne accessibile il fascino particolarissimo ai profani occorreva fornire loro almeno le chiavi essenziali per la soluzione; così è nata questa guida.
Nel libro, però, lei sostiene qualche cosa di più: che i rebus sono una metafora della vita. Che cosa intende dire?
R. Questo è vero in linea generale: come nei rebus, spesso anche nella vita reale sotto la realtà apparente si nasconde una verità nascosta che bisogna saper leggere. Ma è più impressionante l’analogia tra i rebus e i sogni; lo ha detto per primo Freud: come nei rebus, anche nei sogni noi vediamo delle immagini, talvolta surreali, delle quali dobbiamo cercare il significato nascosto. E in entrambi i casi c’è una tecnica per farlo.
Lei parla anche della somiglianza tra la soluzione del rebus e quella di un giallo.
R. Sì: il solutore è un po’ come il detective che si trova di fronte a diversi indizi e deve capire quali di questi conducono alla scoperta dell’assassino, saperli mettere insieme e trarne le conseguenze. E come il lettore del giallo prova piacere non solo se riesce a trovare l’assassino prima della fine del libro, ma anche a lasciarsi condurre per mano fino alla scoperta nell’ultima pagina, allo stesso modo, quando un rebus è veramente bello, si prova un piacere straordinario non solo se si riesce a risolverlo, ma anche nell’ammirare la metamorfosi del testo apprendendo la soluzione senza essere riusciti a trovarla.
Questo riuscire a scorgere il messaggio che si nasconde sotto le cose vale anche per la politica?
R. Vale nel campo della politica più che in tanti altri! Se l’essenza del rebus è il testo bisenso, cioè il testo che ha un primo significato corrispondente alla prima apparenza e un secondo diverso ma più “vero”, la politica è piena di rebus. E il buon politico deve saperli risolvere in fretta. Il linguaggio dei politici è spesso strutturato in modo da significare una cosa per il grande pubblico e un’altra per gli addetti ai lavori.
Non è bello quello che sta dicendo della politica.
R. Ma in qualche misura è inevitabile che le cose vadano così: non bisogna scandalizzarsene troppo. Perché il discorso politico è rivolto, al tempo stesso, alla grande massa degli elettori e al ristretto novero degli addetti ai lavori. E questo non accade solo nell’agone politico.
Intende dire che la doppiezza, nel linguaggio dei politici, è inevitabile?
R. Mettiamola così: la doppiezza è il risultato della cattiva politica. La buona politica è quella che trova una sintesi nella dialettica fra l’esigenza di farsi capire e approvare dalla grande massa degli elettori e quella di fare le cose giuste, molto spesso impopolari.
Come ha vissuto Lei questa dialettica?
R. L’ho vissuta come una sfida quotidiana, più problematica di quanto non fosse per gli altri politici che mi stavano intorno. Lo studioso che viene prestato alla politica – come nel mio caso – si trova inevitabilmente nell’alternativa tra dire le cose gradite al grande pubblico e dire le cose che sa essere necessarie per il bene del Paese. La difficoltà sta proprio nel far capire agli elettori la verità nascosta sotto le apparenze; e nel raccogliere il loro consenso su scelte che a prima vista appaiono contrarie ai loro interessi.
Cosa le ha dato la politica?
R. La percezione di essere davvero al servizio del mio Paese. Quando sono stato eletto per la seconda volta, nel 2008, ho lasciato non solo l’insegnamento, ma anche un’attività professionale che portava il mio reddito a essere tre volte quello di un parlamentare; però da quel momento ho avuto la percezione che stavo restituendo al mio Paese quel che avevo ricevuto nella prima parte della vita. Avevo un progetto un po’ controcorrente, ma che molti elettori capivano e sostenevano; e a realizzarlo dedicavo tutte le mie energie.
Quale progetto?
R. Quello del codice semplificato del lavoro: la riduzione dell’intero compendio delle norme che disciplinano questo contratto in una settantina di articoli del Codice civile, facilmente leggibili da tutti e traducibili in inglese. Su quel mio progetto nel 2009 raccolsi le firme di più di metà dei senatori del gruppo Pd. Negli anni seguenti quel progetto ebbe un notevole ruolo nel determinare le scelte compiute prima dal Governo Monti, poi dal Governo Renzi.
Cosa l’ha delusa della politica?
R. La scoperta che la maggior parte delle scelte che contano viene decisa fuori dal Parlamento. Al quale troppo spesso viene affidato un compito più notarile che di vera elaborazione delle scelte stesse.
La sua passione per il diritto del lavoro come era nata?
R. Fin da bambino ero stato un discepolo di don Lorenzo Milani, che mi diceva: “Ricordati che da grande dovrai restituire tutto; e per restituire hai due modi: fare l’insegnante, oppure il sindacalista”. A vent’anni scelsi di fare il sindacalista, e dunque la strada era obbligata: dovevo dedicarmi al diritto del lavoro.
Per le sue proposte di riforma lei è finito nel mirino delle Br. Cosa ricorda di quel periodo?
R. Ci sono state due fasi: una prima, tra gli anni ’70 e i ’90, nella quale non ero a rischio più di chiunque altro. Mia moglie e io mettevamo in conto di poter essere colpiti, ma era lo stesso rischio che correvano moltissime persone. Cominciai a sentirmi molto più a rischio quando nel 1999, dopo l’assassinio di Massimo D’Antona, il ministro dei Trasporti Bersani mi chiese di sostituirlo nel consiglio di amministrazione dell’Enav, dove lui aveva lavorato per mettere un po’ di ordine in un sistema di relazioni sindacali impazzito: si contavano fino a 300 scioperi all’anno degli uomini-radar. E i suoi assassini erano ancora in circolazione.
A prenderla personalmente di mira, però, fu la generazione successiva dei brigatisti, le “nuove Br”. Se l’aspettava?
R. No. Dopo lo scontro a fuoco del 2003 nel quale perse la vita Mario Galesi, venne arrestata Desdemona Lioce, e il gruppo responsabile degli assassinii di Massimo D’Antona e Marco Biagi venne sgominato, pensavo che il pericolo fosse cessato. Tanto che chiesi che mi venisse tolta la scorta. Ma il prefetto mi chiamò in forma molto riservata per spiegarmi che non era proprio il caso.
Nel corso del processo lei chiese di non essere considerato un simbolo da abbattere ma una persona.
R. Era un tentativo di difendermi: è molto più facile sparare a un simbolo che a una persona. Chi vuol sparare ha bisogno di convincersi che sta solo abbattendo un simbolo.
I lavoratori oggi sono più o meno tutelati rispetto all’Italia in cui veniva varato lo Statuto dei lavoratori?
R. I dipendenti a tempo indeterminato delle aziende di dimensioni grandi o medie oggi sono esposti a un rischio di perdita del posto maggiore rispetto ad allora. Ma non per il mutamento della disciplina dei licenziamenti: è il ritmo di obsolescenza delle tecniche applicate, quindi anche delle aziende stesse, che è fortemente aumentato.
E gli altri?
R. L’altra metà dei lavoratori, siano essi dipendenti di piccole imprese, oppure dipendenti a termine, o collaboratori parasubordinati, gode un po’ più ampiamente degli ammortizzatori sociali rispetto a mezzo secolo fa, ma in compenso soffre anch’essa della maggiore instabilità, quando non addirittura volatilità, del tessuto produttivo.
 [5]Nel suo libro L’intelligenza del lavoro lei disegna una società in cui è addirittura il lavoratore a scegliersi l’azienda. In un’epoca in cui il lavoro manca non le sembra un paradosso?
[5]Nel suo libro L’intelligenza del lavoro lei disegna una società in cui è addirittura il lavoratore a scegliersi l’azienda. In un’epoca in cui il lavoro manca non le sembra un paradosso?
R. Anche in questo periodo di crisi una metà abbondante delle persone è in grado di scegliere nel mercato del lavoro. Tanto è vero che la mobilità spontanea è vivacissima: basta vedere il numero delle cessazioni del rapporto non determinate da licenziamento e i dati impressionanti sui contatti che si stabiliscono fra domanda e offerta nei siti web che forniscono il servizio di mediazione. Il problema sociale riguarda l’altra metà delle persone: quelle che non possono avvalersi delle reti professionali, parentali, amicali, cui occorrerebbe un mercato innervato di servizi di orientamento, informazione, formazione mirata agli sbocchi esistenti, assistenza alla mobilità. Tutti servizi di cui dispongono i lavoratori a nord delle Alpi, ma non da noi.
Ma se il lavoro non c’è?
R. Certo, la domanda di lavoro in Italia è più debole di quel che potrebbe essere. Però resta il fatto che in questa fase di ripresa economica le imprese cercano persone che non trovano. Un terzo dei nuovi posti di lavoro che si aprono resta a lungo scoperto per la difficoltà di trovare le persone idonee. Possiamo considerare anche questo un rebus: l’apparenza è quella del lavoro che non c’è, ma sotto questa apparenza si nascondono dei grandi giacimenti occupazionali inutilizzati.
Lei però ora sta lavorando a un progetto concreto su questo terreno. Vuole dirci di che cosa si tratta?
R. Cessata la carica parlamentare, il sindaco di Milano mi ha chiesto di occuparmi – gratuitamente, s’intende – insieme a tre altre persone molto esperte, dell’Agenzia per il lavoro e la formazione della Città metropolitana, l’AFOL.
E a che cosa state lavorando?
R. Abbiamo messo a punto il progetto dello Hub Lavoro, un grande open space nel centro della città, dove chiunque cerchi un’occupazione possa trovare i servizi di prima informazione sui servizi pubblici e privati disponibili, orientamento, profilazione, job counseling, prendendo a modello le migliori esperienze straniere in questo campo. Ora abbiamo ottenuto gli spazi e fra pochi m [6]esi questa struttura diventerà operativa.
[6]esi questa struttura diventerà operativa.
Che professore è stato?
R. Gli studenti hanno apprezzato il mio modo di insegnare: anche a decenni di distanza molti mi sono ancora legati, mi scrivono e leggono ancora quello che scrivo. Mi lusingo di avere costruito qualche cosa di qualche peso: il Dipartimento di Scienze del Lavoro dell’Università di Milano è stato una cosa del tutto nuova nel panorama italiano.
Che cosa consiglierebbe a un giovane che sta finendo la maturità e deve iscriversi all’università? Come deve orientarsi, tra passione e mercato del lavoro?
Di intervistare approfonditamente, su ogni insegnamento e ogni aspetto della didattica, almeno due o tre degli studenti che stanno finendo il primo anno e due o tre di quelli che si stanno laureando in ciascuna delle facoltà che rientrano nelle sue possibili scelte. Anche l’Università, a suo modo, è un rebus per chi ci si avvicina per la prima volta: ha una sua realtà apparente e una nascosta.
