Una battaglia durata mezzo secolo per superare l’arretratezza del sistema italiano dei servizi al mercato del lavoro, tra le resistenze dell’intero arco delle forze politiche e l’indifferenza delle organizzazioni sindacali, dimentiche della loro vocazione originaria di protezione dei lavoratori non solo in azienda ma anche nel mercato
.
Intervista a cura di Lilli Casano e Silvia Spattini pubblicata sul Bollettino Adapt l’8 aprile 2024 – L’intervista è parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei miei scritti pubblicati nell’arco degli ultimi 50 anni; questa prende spunto dal mio articolo Appunti per un rilancio delle politiche attive del lavoro in Italia, nella rivista Diritto delle Relazioni Industriali, 2022, 1, pp. 161-173 – Su questo sito sono disponibili anche le interviste precedenti della stessa serie già pubblicate: dall’ultima, L’anima laburista della Legge Biagi, si può risalire a tutte le altre
.
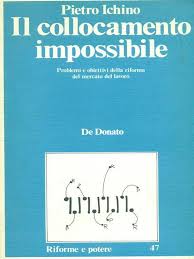 Il tuo interesse per la disciplina del mercato del lavoro e in particolare dei servizi di collocamento risale a molto tempo prima di questo saggio del 2022 sulle politiche attive: il libro Il collocamento impossibile era uscito nel 1982. Nei quarant’anni che separano i due scritti è passata molta acqua sotto i ponti.
Il tuo interesse per la disciplina del mercato del lavoro e in particolare dei servizi di collocamento risale a molto tempo prima di questo saggio del 2022 sulle politiche attive: il libro Il collocamento impossibile era uscito nel 1982. Nei quarant’anni che separano i due scritti è passata molta acqua sotto i ponti.
Sì e no. Certo, in questi quattro decenni sono stati abrogati in un primo tempo, nel 1991, il regime generale dell’avviamento al lavoro su richiesta numerica, qualche anno dopo il regime del monopolio statale dei servizi di collocamento e il divieto di attività delle agenzie private per l’impiego…
… riforme tutte e tre da te sostenute con molto vigore negli scritti degli anni ’80 e ’90.
La prima, cioè la liberalizzazione dell’incontro fra domanda e offerta, era diventata un mio terreno prioritario di impegno nel corso dell’VIII legislatura (1979-83), quando fui molto impegnato in seno alla Commissione Lavoro della Camera su questa materia. In seguito, promossi attivamente le altre due riforme anche con l’iniziativa giudiziale che portò alla sentenza Job Centre II del 1997, all’esito di un procedimento avviato nel 1994, difendendo la causa davanti alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. Quella sentenza, che stabilì l’abuso di posizione dominante del monopolio pubblico del collocamento, arrivò dopo una battaglia ventennale, che condussi da solo, in un contesto politico in cui erano schierate compattamente in difesa del monopolio statale non soltanto la sinistra politica (PCI e PSI), ma anche la DC, fortemente interessata a mantenere il controllo della rete del collocamento pubblico. Sul piano giudiziario, nel corso degli anni ’80 persino la Corte costituzionale era giunta a sostenere la tesi assurda secondo cui la regola dell’avviamento al lavoro su richiesta numerica in regime di monopolio pubblico del servizio di collocamento doveva considerarsi come una conseguenza necessaria della corretta applicazione dei principi fondamentali in materia di lavoro (sentenza n. 248 del 1986, che commentai molto negativamente in DLRI, 1988, pp. 1-41). Non c’è dubbio, dunque, che il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, il quale ha prontamente dato attuazione nel nostro ordinamento alla sentenza Job Centre II della Corte di Giustizia, superando il monopolio pubblico del collocamento e consentendo anche a soggetti privati l’esercizio dell’attività di intermediazione, abbia segnato una svolta importantissima nel nostro ordinamento, poi consolidata e perfezionata con la legge Biagi del 2003. Resta il fatto, tuttavia, che a quella svolta non ha corrisposto un mutamento adeguato né nella mentalità e cultura dell’apparato ministeriale preposto al governo del mercato del lavoro, né in quelle degli apparati sindacali, i quali hanno continuato a occuparsi soltanto della protezione degli interessi dei lavoratori nei luoghi di lavoro, trascurando pressoché totalmente l’efficienza e l’efficacia della rete dei servizi, dei quali il mercato del lavoro ha assoluta necessità per funzionare a dovere.
Veniamo alle vicende più recenti. L’alternativa accentramento/ decentramento ha occupato a lungo un posto di primo piano nel dibattito sulle politiche attive del lavoro. Nel tuo saggio del 2022 parli della necessità di un sistema “rigoroso” di sussidiarietà, e solleciti un recupero della capacità operativa dell’ANPAL, soprattutto sul fronte del monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati della Regioni, criticando la scelta di reincorporare l’agenzia nella struttura del Ministero del lavoro. Oggi che la vicenda dell’ANPAL sta giungendo all’epilogo, con la sua imminente soppressione, tramonta definitivamente il progetto di un’agenzia tecnica autonoma sull’esempio delle migliori pratiche europee?
Di definitivo, in questo campo, non c’è nulla; e aggiungo: per fortuna, visto che il quadro delle strutture esistenti non è esaltante. Certo, con l’abbandono del progetto del 2015 l’Italia fa un grosso passo indietro su questo terreno. L’importanza di una Agenzia nazionale autonoma sta in questo: la materia delle politiche attive è di competenza delle Regioni, le quali presentano in questo campo livelli di capacità operativa e di efficacia dei servizi molto differenziati; sarebbe dunque indispensabile un organismo capace di valutare in modo imparziale i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi regionali e, dove questi siano troppo bassi, di intervenire in via sussidiaria per supportare l’amministrazione in difficoltà e nei casi più gravi sostituirsi ad essa. Un meccanismo istituzionale di questo genere presuppone l’indipendenza dell’organismo in questione dal Governo centrale: altrimenti il suo surrogarsi all’amministrazione regionale inadempiente potrebbe essere sospettato di essere dettato da ostilità politica invece che da motivi tecnici.
Quali sono stati, a tuo parere, i fattori che hanno portato al fallimento di questa esperienza nel nostro Paese?
Il primo errore che è stato compiuto consiste nell’aver imposto come Direttore generale dell’ANPAL, quando essa è stata costituita, il titolare della Direzione generale del ministero competente per la stessa materia: in questo modo si è favorito l’assorbimento da parte della nuova agenzia della stessa mentalità e dello stesso modus operandi che fino a quel momento avevano caratterizzato l’amministrazione ministeriale. Un secondo errore è stato commesso dal neo-insediato Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL, quando non ha vincolato l’operato del Direttore generale al conseguimento di obiettivi specifici, misurabili, legati a scadenze temporali precise, di attuazione della riforma delle politiche attive delineata nei decreti delegati n. 22 e n. 150 del 2015. Questo consentì al Direttore stesso una sostanziale irresponsabilità rispetto a quegli obiettivi e impermeabilità rispetto al potere direttivo del vertice della struttura: nel contrasto con il Presidente egli poteva mostrarsi indifferente; non aveva nulla da perdere. Mutato il quadro politico, nella XVIII legislatura, la presidenza dell’agenzia è stata affidata a un docente del Mississippi che aveva la pretesa di poter esercitare la funzione da remoto, per di più con un programma operativo a dir poco nebuloso: fatto sta che sotto la sua presidenza l’attività dell’ANPAL è rimasta pressoché del tutto paralizzata.
 Come si può rimediare a questo disastro?
Come si può rimediare a questo disastro?
Ora l’ANPAL come soggetto dotato di autonomia operativa non c’è più e la sua struttura è stata riportata in seno all’amministrazione ministeriale. Siamo dunque tornati al punto da cui eravamo partiti dieci anni fa. Possiamo pensare che questa sia l’attrezzatura adatta per un rilancio serio delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese? La mia risposta è molto netta: no, non è l’attrezzatura adatta. In tutti gli altri maggiori Paesi europei la gestione di questa materia al livello nazionale è affidata a un’agenzia indipendente della cui azione sia possibile rilevare e misurare l’efficacia, capace a sua volta di gestire in modo credibile, trasparente e imparziale sistemi di monitoraggio dell’efficacia dei servizi attivati dalle Regioni; capace di individuare e valorizzare le competenze professionali necessarie e di operare in modo tempestivo e flessibile secondo le esigenze che di volta in volta si manifestano; capace, per esempio, di intervenire con il personale adeguato, ma solo per il tempo strettamente necessario, a supporto delle amministrazioni regionali che non riescono a soddisfare i livelli essenziali delle prestazioni. L’amministrazione ministeriale non è in grado di fare questo. Non mi sembra, però, che un progetto di questo genere sia all’ordine del giorno, né nell’agenda del Governo, né in quella dell’opposizione.
Nel saggio del 2022 proponi anche una integrazione fra l’attività dell’agenzia per le politiche attive e l’Inps.
La proposta risponde all’esigenza di attivare gli incentivi giusti, necessari per il buon funzionamento della condizionalità del sostegno del reddito ai disoccupati. Poiché questo viene erogato dall’Inps, sarebbe molto opportuno che l’Inps stesso avesse voce in capitolo nella predisposizione dei percorsi di formazione necessari per avviare i disoccupati alle moltissime posizioni di lavoro che restano scoperte a causa della mancanza della manodopera adatta e nel controllo della disponibilità effettiva dei percettori dell’indennità di disoccupazione per questi percorsi. Se anche soltanto il 10 per cento del risparmio ottenuto con l’attivazione effettiva della condizionalità venisse destinato a premiare il personale cui questa funzione è affidata, avremmo probabilmente l’effetto di un forte risparmio nella spesa pubblica per il sostegno del reddito dei disoccupati e una significativa riduzione della disoccupazione.
Le politiche attive sono ancora oggi concepite principalmente come strumento per il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati in un’ottica rimediale e non in un’ottica preventiva o, meglio ancora, di gestione ordinaria e continuativa delle transizioni occupazionali. Per questo capitoli strategici come l’informazione e l’orientamento professionale continuano a restare nell’ombra, o scontano (come nel caso dell’orientamento scolastico, recentemente oggetto di un importante intervento di potenziamento) approcci settoriali poco pragmatici. Quali potrebbero essere i passi per arrivare alla realizzazione di un sistema capillare di orientamento realmente accessibile a tutti, in ogni fase del percorso biografico e professionale?
L’orientamento scolastico e professionale è il primo, indispensabile, anello della catena: senza di esso l’intero sistema dei servizi al mercato del lavoro è condannato a un livello di efficienza basso. Nei Paesi dove esso funziona bene, si articola su due livelli. Il primo è quello che riguarda gli adolescenti: un servizio capace di raggiungere ogni adolescente all’uscita di ogni ciclo di scuola media inferiore o superiore, tracciare il profilo delle sue capacità e quello delle sue aspirazioni, metterli a confronto e rilevare eventuali incongruenze, segnalarle all’adolescente e alla sua famiglia e indicare la via migliore per superarle. L’altro livello è quello dell’orientamento per le persone adulte: quelle che hanno già compiuto almeno un’esperienza lavorativa, ma hanno perso il posto di lavoro, oppure hanno dovuto interrompere l’attività per la maternità, o per qualsiasi altro motivo, oppure ancora semplicemente sono interessate a guardarsi intorno per trovare un’occupazione nella quale le loro capacità siano meglio valorizzate rispetto a quanto avviene nell’azienda in cui attualmente lavorano. Questa parte del servizio di orientamento richiede delle sedi molto visibili, facilmente reperibili – a differenza degli uffici di collocamento del secolo scorso – nelle zone centrali del tessuto cittadino e nel web e immediatamente accessibili, possibilmente specializzate in relazione ai diversi segmenti di offerta di manodopera cui si rivolgono: adulti che hanno perduto il posto o comunque ne cercano un altro, donne che intendono rientrare nel tessuto produttivo dopo la maternità, giovani che affrontano per la prima volta il mondo del lavoro, immigrati, persone con disabilità. In relazione a ciascuna di queste categorie occorrerebbe attivare degli hub dove le persone interessate possano trovare non solo il servizio di profilazione di cui ho detto prima, ma anche le informazioni sulle opportunità occupazionali esistenti e sui servizi di formazione o addestramento disponibili per accedervi.
 Stai delineando un nuovo modo d’essere dell’articolazione periferica dell’amministrazione pubblica del Lavoro?
Stai delineando un nuovo modo d’essere dell’articolazione periferica dell’amministrazione pubblica del Lavoro?
Sì: la prospettiva dovrebbe essere quella di una tendenziale sparizione dei Centri per l’Impiego intesi come sportelli per pratiche burocratiche, esattamente come stanno sparendo gli sportelli bancari perché sostituiti dal collegamento a distanza via web (qualche cosa di questo genere sta incominciando ad accadere a Milano, per mezzo di una applicazione informatica attivata dall’agenzia metropolitana che gestisce i CpI). Le articolazioni periferiche dell’amministrazione pubblica del Lavoro dovrebbero concretarsi sempre di più negli hub di cui ho detto, destinati a diventare il luogo dove le persone si recano per avere un servizio di assistenza nel mercato: in primo luogo per mettere a fuoco il proprio problema occupazionale ed essere indirizzate ai servizi idonei a risolverlo. Indispensabili come luoghi di servizio ben visibili nei centri abitati, anche questi hub dovranno, peraltro, essere accessibili al tempo stesso via web e capaci di offrire esattamente gli stessi servizi mediante collegamento a distanza: il cosiddetto mirroring della struttura fisica nella struttura digitale, del quale abbiamo alcuni notevoli esempi nel panorama internazionale.
Quali professionalità sarebbero richieste, e quali soggetti dovrebbero concorrere alla costruzione di questo importante pilastro delle politiche attive?
I nostri servizi per l’impiego dispongono anche di bravi orientatori, ma in numero ridottissimo rispetto a quanto sarebbe necessario per un servizio capillare come quello di cui si è detto. Da noi l’orientamento scolastico e professionale per gli adolescenti si fa inviando qualcuno una volta all’anno a parlare del mercato del lavoro alle classi terze o quinte delle medie inferiori o dei licei, riunite in aula magna; ma per orientare efficacemente i giovani e prevenire la piaga dei NEET – Not in Employment, Education or Training – occorre tutt’altro. Un servizio efficiente dovrebbe articolarsi in una fase di profilazione personale, che può essere svolta interamente mediante programmi fondati sull’intelligenza artificiale, e una fase di colloquio tra la persona interessata e un orientatore specializzato in relazione ai problemi peculiari della categoria cui la persona appartiene. Il problema è che, per funzionare bene, il servizio di orientamento dovrebbe disporre di un dato di cui in Italia non disponiamo, o disponiamo troppo poco.
A che cosa ti riferisci?
Al dato circa l’efficacia dei corsi di formazione o addestramento. Nel saggio da cui abbiamo preso le mosse sostengo che questa misura è data principalmente dal tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi di chi l’ha ricevuta. Per poterne disporre occorrerebbe una anagrafe nazionale della formazione i cui dati venissero incrociati con quelli delle Comunicazioni Obbligatorie al ministero del Lavoro circa i nuovi contratti di lavoro, delle iscrizioni agli albi od ordini professionali, nonché delle iscrizioni alle liste di disoccupazione: questo incrocio di dati consentirebbe di misurare il tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, dunque l’efficacia di ciascun corso di formazione o addestramento finanziato con il denaro pubblico. E consentirebbe di consigliare a giovani e adulti i percorsi migliori su cui investire il proprio tempo per accedere alle opportunità occupazionali cui aspirano. Ma in Italia, per la maggior parte dei corsi di formazione, questo dato non è disponibile, nonostante che sia l’anagrafe della formazione sia l’incrocio dei suoi dati con quelli dei flussi occupazionali siano oggetto di una previsione specifica contenuta nelle norme di attuazione del Jobs Act (precisamente negli articoli 13-16 del d.lgs. n. 150/2015).
In diversi altri tuoi scritti hai sostenuto che il nostro Paese avrebbe urgente bisogno di cambiare radicalmente il modo in cui vengono affrontate le crisi aziendali e i conseguenti problemi occupazionali. Puoi spiegare meglio il tuo pensiero a questo riguardo?
L’Italia soffre di una stagnazione ormai ultraventennale della produttività del lavoro e conseguentemente dei livelli retributivi. Un modo per affrontare questo problema consisterebbe nel favorire in tutti i modi il trasferimento delle persone dalle aziende meno produttive, marginali o sub-marginali nei rispettivi mercati, a quelle più produttive, più capaci di valorizzare le loro capacità. Di fronte a una crisi aziendale di dimensioni rilevanti, la politica giusta non è quella mirata a tenere in vita a tutti i costi la struttura produttiva interessata, incoraggiando i lavoratori a restarvi attaccati con le unghie e coi denti il più a lungo possibile. Questo modo di affrontare le crisi aziendali sarebbe giustificato se l’alternativa al tenere in vita a tutti i costi quelle strutture produttive fosse soltanto la disoccupazione di chi in esse ha lavorato finora; ma non è così: l’indagine permanente Excelsior svolta da Unioncamere e Anpal avverte che molte centinaia di migliaia di posti di lavoro nelle imprese di tutti i settori e a tutti i livelli professionali restano permanentemente scoperti per la difficoltà che le imprese stesse incontrano nella ricerca delle persone di cui hanno bisogno. Le crisi aziendali andrebbero dunque affrontate coll’attivare subito i percorsi di informazione e formazione mirata ad altri sbocchi occupazionali concretamente possibili, assicurando alle persone interessate la continuità del reddito e ogni possibile assistenza nella transizione. La stagnazione della produttività media del lavoro in Italia dipende anche dal fatto che manteniamo in vita con la respirazione artificiale moltissime aziende che meriterebbero di essere chiuse. A cominciare da tante “partecipate” pubbliche che servono a poco o a niente.
Stai dicendo che il Governo sbaglia a tenere aperti i “tavoli di crisi” al ministero dello Sviluppo, affrontando i problemi occupazionali essenzialmente con misure di politica industriale, perché essi dovrebbero essere aperti semmai al ministero del Lavoro e affrontati per mezzo delle politiche attive del lavoro?
Non arrivo ad affermare questo: vi sono anche dei casi nei quali è sensato affrontare la crisi aziendale con misure di politica industriale. Contesto, però, l’atteggiamento generale che si esprime in titoli di giornale, del tipo “180.000 posti a rischio, se non si risolvono positivamente 80 tavoli di crisi aperti al ministero di via Veneto”. 180.000 cessazioni di rapporti di lavoro sono meno del 2 percento rispetto al totale della forza-lavoro dipendente; e, come si è visto, sono più di dieci volte tanto i contratti di lavoro di lunga durata che vengono stipulati ogni anno nel nostro Paese e più di tre volte tanto i posti di lavoro che restano permanentemente scoperti perché le imprese più produttive non trovano le persone di cui hanno bisogno. Il mismatch si verifica, in varia misura, in tutti i settori produttivi e a tutti i livelli di professionalità. Invece di tenere in freezer per anni i lavoratori delle aziende in crisi, collocandoli in cassa integrazione a zero ore e allontanandoli dal mercato del lavoro sempre di più ogni mese che passa, costerebbe molto meno e renderebbe infinitamente di più sul piano della produttività media del lavoro e su quello del benessere delle persone attivare subito i percorsi che possono consentire loro di candidarsi ai posti vacanti nelle aziende più forti. Considerate in questa ottica e trattate di conseguenza, le crisi aziendali potrebbero essere trasformate in un’opportunità positiva per le persone che vi sono coinvolte.
 A proposito del fenomeno del mismatch a cui hai accennato, un altro capitolo centrale, da decenni in attesa di risposte concrete, è quello della costruzione di una vera e propria infrastruttura di labour market intelligence in grado di fornire agli operatori dati aggiornati sui fabbisogni espressi dai sistemi locali del lavoro e strumenti operativi per la skills’ gap analysis e la pianificazione degli interventi. Su questo fronte, nell’ambito del programma GOL, Anpal Servizi ha avviato una sperimentazione, un cruscotto interattivo che utilizza fonti informative come la classificazione delle professioni Istat (CP-Istat 2011), il Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie (Sisco, del Ministero del lavoro) e l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Inapp). Ritieni che questa sia la strada giusta?
A proposito del fenomeno del mismatch a cui hai accennato, un altro capitolo centrale, da decenni in attesa di risposte concrete, è quello della costruzione di una vera e propria infrastruttura di labour market intelligence in grado di fornire agli operatori dati aggiornati sui fabbisogni espressi dai sistemi locali del lavoro e strumenti operativi per la skills’ gap analysis e la pianificazione degli interventi. Su questo fronte, nell’ambito del programma GOL, Anpal Servizi ha avviato una sperimentazione, un cruscotto interattivo che utilizza fonti informative come la classificazione delle professioni Istat (CP-Istat 2011), il Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie (Sisco, del Ministero del lavoro) e l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Inapp). Ritieni che questa sia la strada giusta?
Il “cruscotto” di Anpal Servizi e l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni dell’Inapp costituiscono l’ultimo capitolo di una storia molto lunga. All’origine c’era il Dizionario delle professioni del ministero del Lavoro, la cui prima edizione per i tipi del Poligrafico dello Stato risaliva addirittura al 1966: conteneva molte migliaia di profili professionali, ciascuno con il suo codice, corrispondenti ad altrettanti mestieri. Quel Dizionario è oggi una fonte preziosa di informazioni anche dettagliatissime su quello che si faceva nelle aziende di tutti i settori negli anni ’50 e ’60. Aprendo a caso la prima edizione, alle pagine 64 e 65 ci trovo per esempio il “biscionatore – 09.04.10”, dove i primi due numeri indicano il settore e il sotto-settore produttivo (in questo caso il tessile-abbigliamento, cappelli da uomo), oppure il “borlonatore – 09.12.09” (pulitore e levigatore del materiale per la produzione di bottoni). I mestieri erano ripartiti per genere: così, per esempio, compariva il mestiere del “bobinatore – 17.03.04” che cura gli avvolgimenti per la costruzione di motori elettrici, ma anche quello della “bobinatrice – 08.02.06” che cura l’avvolgimento di fili nell’azienda tessile. L’idea era che uno si iscrivesse nelle liste di collocamento con una determinata qualifica, per esempio “borlonatore”; e che poi, non appena un’impresa avesse richiesto un “borlonatore” l’ufficio lo avviasse a lavorare lì. La cosa, ovviamente, non poteva funzionare bene, perché nella maggior parte dei casi l’area di competenza della sezione di collocamento non ospitava alcuna impresa produttrice di bottoni; e se per caso ce n’era una produttrice di cappelli che cercava un biscionatore, il borlonatore non sarebbe stato avviato, a meno che – come di regola accadeva – il collocatore, debitamente “incentivato”, non gli avesse segnalato l’opportunità di iscriversi con l’altra qualifica. Fu così che verso la fine degli anni ’70, quando si incominciò ad affrontare la questione dell’inefficienza pressoché totale del meccanismo del collocamento pubblico, si pensò di impostare il meccanismo dell’incontro fra domanda e offerta sulla base di “fasce di professionalità” che consentissero di individuare non solo lo specifico mestiere imparato da un giovane, o quello svolto in precedenza da un adulto, ma l’area più ampia nella quale le loro ricerche di occupazione potessero utilmente svolgersi. Il ministro del Lavoro diede dunque incarico all’Isfol di delineare una griglia di “fasce” che potesse consentire di reimpostare il meccanismo del collocamento rendendolo più efficace; senonché l’incarico risultò difficilissimo da adempiere. Accantonata l’idea delle “fasce”, l’Isfol ripiegò sul progetto di una griglia di “aree e profili di professionalità” che potesse aiutare la domanda e l’offerta a incontrarsi: ne nacque un Repertorio delle professioni, edito nel 1987 sempre dal Poligrafico dello Stato, che si proponeva come strumento per individuare “tutte le principali professioni che un giovane o un lavoratore in mobilità può realisticamente prefiggersi di esercitare in Italia”. Un progetto titanico, che però produsse un topolino: nella prefazione si legge che il Repertorio “per quest’anno […] contiene schede informative relative a 115 professioni, scelte tra le più rappresentative quantitativamente, per contenuto innovativo e per potenzialità occupazionali”. Anni di lavoro per un risultato totalmente inutile ai fini della rivitalizzazione di un servizio di collocamento, che all’epoca era gestito ancora in regime di monopolio statale. Ma non risulta che alcun dirigente dell’Isfol abbia perso il posto per questo.
Vuoi dire che l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni realizzato ora dall’Inapp è una riedizione del Repertorio del 1987, o addirittura del Dizionario del 1966?
Inapp è il nuovo nome che è stato dato all’Isfol nel 2016, ma la struttura e il patrimonio tecnico e culturale sono sempre quelli. L’Atlante non è più un volumone pubblicato dal Poligrafico dello Stato, ma un sito web. L’Inapp lo presenta come “attuazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” previsto dal decreto legislativo n. 13 del 2013. Sono dunque trascorsi più di 10 anni da quando la creazione di questo “repertorio” è stata prevista dalla legge (in linea di perfetta continuità, peraltro, con quanto fatto nei decenni precedenti, di cui si è detto), ma non sono bastati: diverse parti dell’opera sono ancora “in allestimento”. Si stenta, comunque, a capire in che cosa essenzialmente l’opera si distingua dalle precedenti di cui si è detto. A chi apre la pagina web dell’Atlante si presenta un indice di 24 settori economico-professionali (Agricoltura, Chimica, Edilizia, Meccanica, ecc.), ciascuno dei quali è ripartito in “sequenze di processo” (per esempio, per il settore meccanico: produzione di metalli, saldatura, montaggio, istallazione, manutenzione di macchinari, ecc.), le quali sono a loro volta ripartite in “aree di attività-ADA”, ognuna delle quali corrisponde a una qualifica specifica (per esempio: laminazione, montaggio, collaudo, ecc.), ciascuna con l’indicazione del suo codice statistico. Ora, comprendo bene come un repertorio di questo genere possa presentare qualche utilità per la classificazione e il censimento delle attività a fini statistici, o per la comunicazione fra banche-dati diverse e anche di Paesi diversi. Ma non riesco a vedere una differenza sostanziale tra le ADA contenute in questo Atlante e i mestieri contenuti nel Dizionario del 1966: ora le ADA sono indicate come “laminazione”, “montaggio”, “collaudo”, allora i mestieri erano indicati con le parole “laminatore”, “montatore”, “collaudatore”; ma qual è la novità sostanziale? Certo, nel Dizionario del 1966 non troveremo il programmatore informatico, ma non riesco a vedere in che cosa consista la differenza concettuale dello strumento rispetto ai precedenti. Mi sembra che, a sessant’anni di distanza, l’apparato pubblico preposto alle politiche attive del lavoro continui a pestare l’acqua nel mortaio, a essere una montagna capace soltanto di partorire topolini. Per altro verso, nel tessuto produttivo reale il panorama dei profili professionali è in costante e rapidissima evoluzione, al punto che stentano a registrarne in tempo utile i mutamenti anche i data-base elaborati e aggiornati di continuo dalle grandi agenzie per l’impiego in funzione della loro opera di mediazione esercitata quotidianamente: vi è motivo di dubitare che l’Atlante dell’Inapp, anche quando fra un altro decennio sarà stato finalmente completato, riesca a essere più aggiornato.
Si possono immaginare sistemi alternativi, o almeno complementari, più vicini alla realtà del lavoro nelle imprese e nei territori e sensibili alle caratteristiche qualitative della domanda e dell’offerta di lavoro?
Certo che sì: il panorama internazionale offre numerose esperienze positive in questo campo. E non solo il panorama internazionale: penso per esempio al progetto attuato da Manpower Italia sull’asse lombardo-romagnolo della Via Emilia, inizialmente in funzione delle esigenze della filiera della meccatronica, poi esteso al settore della moda e a quello alimentare, con i centri operativi più importanti a Fornovo e a Reggio Emilia; oppure alla capacità manifestata in questi ultimi anni dall’agenzia milanese Afol Metropolitana di intercettare la domanda di manodopera espressa da imprese sempre più in difficoltà nella ricerca delle persone di cui hanno bisogno, per poi attivare subito le persone disponibili sui percorsi di formazione o addestramento necessari. Tutte le esperienze migliori, comunque, confermano che nella maggior parte dei casi la risposta positiva alla domanda delle imprese non consiste nell’avviamento immediato della persona giusta, bensì nell’attivazione del percorso efficace di formazione o addestramento mirato alle esigenze tecniche di ciascuna vacancy. Per questo motivo è indispensabile che l’intero sistema della formazione professionale finanziata con il denaro pubblico sia sottoposto al monitoraggio di efficacia di cui abbiamo parlato prima, in modo che possano essere attivati in questo campo gli incentivi necessari per sgombrare il campo dai corsi di formazione che servono a poco o a niente e concentrare le risorse su quelli che rispondono effettivamente in modo puntuale alle esigenze espresse dal tessuto produttivo.
Le politiche attive sono sempre più spesso un ambito in cui la contrattazione collettiva interviene, e – potremmo dire – è sollecitata ad intervenire. Da questo punto di vista, il Fondo Nuove Competenze è stato indicato in dottrina come esempio di politica attiva di “nuova generazione”, proprio perché è una misura potenzialmente idonea a favorire il raccordo tra dimensioni finora non comunicanti (le politiche pubbliche, da un lato/ le dinamiche organizzative delle imprese, dall’altro) integrando l’azione delle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva e quella dell’attore pubblico. Non sono mancate evidentemente le criticità, ed anche in questo caso non possiamo contare su efficaci strumenti di monitoraggio. Hai fiducia in questa logica di intervento?
Il discorso sulla c.d. “formazione continua” delle persone che sono già impegnate in un rapporto di lavoro è in larga parte diverso rispetto a quello sulla formazione come strumento per l’inserimento nel tessuto produttivo di inoccupati e disoccupati. Le nuove norme sul Fondo Nuove Competenze introdotte nel 2020, poi modificate nel 2022, sono servite per finanziare una rimodulazione dell’orario di lavoro in funzione della riqualificazione delle competenze dei lavoratori. La riduzione di orario finalizzata alla partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi è avvenuta con il coinvolgimento dei sindacati al livello aziendale o territoriale: e questa è una buona notizia. La prima edizione della misura, tuttavia, ha dato solo in parte modesta gli esiti positivi sperati. I ritardi nella predisposizione degli atti amministrativi e l’incapacità delle imprese più piccole di rispondere con accordi aziendali in tempi rapidi alle scadenze previste nel bando hanno favorito le imprese più grandi e organizzate, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, che in poche settimane hanno impostato piani formativi per le proprie aziende e hanno utilizzato la maggior parte delle risorse disponibili. Per altro verso, la non originalità dei piani formativi proposti negli accordi di secondo livello (per lo più formazione collegata al lavoro agile) e l’incapacità di selezionare i lavoratori da formare (nella prima edizione la formazione era diretta per lo più a platee di lavoratori indistinte) hanno indotto il legislatore a ripensare la misura in una duplice direzione: ridurre gli importi rimborsati e indirizzare la formazione impartita verso percorsi più orientati alla transizione ecologica e digitale. Il cospicuo finanziamento per il 2023, pari a un miliardo di euro, a copertura degli oneri connessi alla rimodulazione dell’orario di lavoro, dovrà essere oggetto di un serio monitoraggio da parte dell’ANPAL, o di chi sarà chiamato a svolgerne le funzioni, anche in considerazione della novità introdotta nel 2022 dal d.m. n. 34, che associa il finanziamento della rimodulazione dell’orario di lavoro a un serio progetto formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori corrispondenti a classificazioni internazionali. Le competenze acquisite devono inoltre essere messe in trasparenza, validate o certificate: il monitoraggio è ancora più necessario se si intenderà rendere questa misura strutturale.
Il saggio si chiude con tre argomentazioni tanto chiare ed efficaci quanto lontane dal comune sentire, almeno con riferimento al tema delle politiche attive: l’importanza di imparare dalle buone pratiche internazionali; la relazione profonda tra crescita della produttività e capacità di accompagnare le persone verso le occupazioni produttive, anziché intrappolarle in situazioni di crisi senza uscita; l’incapacità degli standard inderogabili di tutela del lavoro (da soli) di rispondere al problema delle disuguaglianze, e la necessità di tutele che potremmo definire transizionali, per l’accompagnamento delle persone verso un lavoro produttivo e di qualità. In questo delicato equilibrio potrebbe occupare un posto anche la adeguata valorizzazione del cosiddetto lavoro riproduttivo e di cura, formale e informale, che tanto peso ha rispetto ai tradizionali fattori di disuguaglianza (in primis di genere), oltre ad esprimere una domanda crescente di lavoro sempre più qualificato; ma è assai poco presente nelle agende di riforma del lavoro e non conosce una concreta progettualità in materia di politiche attive. Se concordi con questa osservazione, come pensi che si possa colmare il ritardo su questo terreno?
Il grande difetto del cosiddetto “modello mediterraneo” di organizzazione sociale, che caratterizza il nostro Paese insieme agli altri del sud d’Europa, consiste in una doppia penalizzazione del lavoro di cura. Per il fatto di essere tipicamente assegnato alle madri di famiglia al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale, innanzitutto esso non viene retribuito; in secondo luogo, esso viene svalutato sul piano professionale e non è riconosciuto come titolo nel mercato del lavoro. Se confrontiamo quantità e qualità della forza-lavoro italiana con quella dei Paesi del nord-Europa, vediamo che le componenti impiegate nel lavoro industriale e quelle impiegate nel settore terziario sono, in percentuale rispetto alla popolazione in età attiva, di entità abbastanza simile; quella che da noi è enormemente più esigua è la componente dedicata – nell’ambito di un rapporto di lavoro retribuito – ai servizi di cura prestati alle famiglie e alle comunità locali. È proprio il difetto di questa componente che determina il deficit di partecipazione delle persone in età attiva – soprattutto delle donne – al mercato del lavoro nel nostro Paese. Più lavoro di cura reso in forma professionale, comunque riconosciuto e regolarmente retribuito, porterebbe con sé maggiore ricchezza e sicurezza delle famiglie e maggiore parità di genere nel mercato occupazionale. Ma per questo occorrerebbe che la spesa sociale dello Stato italiano non fosse destinata per la maggior parte a finanziare il prepensionamento dei sessantenni, bensì fosse destinata invece all’attivazione di asili-nido, servizi per i disabili, case di riposo per anziani, assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti. Invece abbiamo ancora un largo schieramento di forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, che ancora predicano l’abrogazione della riforma pensionistica del dicembre 2011: come se la questione sociale più urgente consistesse in un abbassamento dell’età media di pensionamento italiana, che è già una delle più basse d’Europa.
 Vedi dunque, a questo riguardo, un difetto generale di consapevolezza politica?
Vedi dunque, a questo riguardo, un difetto generale di consapevolezza politica?
Il discorso riguarda tutto il tema delle politiche del lavoro: dopo la stagione delle riforme, che si è aperta con il “pacchetto Treu” del 1997 ed è proseguita con la legge Biagi del 2003, poi con la legge Fornero del 2012 e il Jobs Act del 2014-2015, la sinistra ha rinnegato tutto quanto è stato fatto in quella stagione, nonostante che per la maggior parte fosse stato fatto da Governi da essa stessa sostenuti, e si è persa nel vagheggiamento di un ritorno all’indietro; la destra, dal canto suo, appare al momento incapace di esprimere un progetto, una visione adeguata alle sfide del presente e del prossimo futuro. Nessuno, comunque, né a sinistra né a destra, sembra considerare come uno scandalo intollerabile che le imprese italiane stentino ormai a trovare metà della manodopera che cercano, in tutti i settori e a tutti i livelli di professionalità, nonostante che il tasso di disoccupazione generale sia ancora sopra il 7 per cento, quello giovanile sopra il 20, e il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro sia ancora di oltre 10 punti al di sotto della media europea. E nessuno, né a destra né a sinistra sembra preoccupato per i primi dati – pesantemente negativi – sugli esiti delle “prese in carico” di disoccupati da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del programma GOL. Così può accadere che l’Agenzia nazionale per le politiche attive venga smantellata, gli apparati pubblici continuino a concepire la propria funzione in chiave soltanto burocratica (mostrandosi soddisfatti per l’alto numero delle “prese in carico” e indifferenti ai relativi esiti occupazionali), nessuno si curi di controllare l’efficacia dei servizi finanziati con il denaro pubblico, e si continui tranquillamente a spendere per le politiche attive meno di un decimo di quello che si spende per le politiche passive, cioè per quelle destinate al mero sostegno del reddito di chi ha perso il lavoro regolare.
.
.
