Non se ne comprendono i problemi se si continua a considerarli come effetti di un monopsonio strutturale: essi nascono soprattutto da difetti di informazione, orientamento, formazione mirata e assistenza alla mobilità – Conseguentemente devono evolvere le tecniche di individuazione e protezione della parte debole
.
Trascrizione dell’esposizione orale della mia relazione al Convegno dell’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, svoltosi il 10 dicembre 2022 – Qui le slides utilizzate per la stessa relazione
.
La riflessione che vi propongo va proprio alla radice della ragion d’essere della materia stessa a cui ho dedicato tutta la mia vita adulta: la materia, cioè, del diritto del lavoro, della protezione del lavoro, del sistema delle relazioni industriali.
Se cerchiamo la ragion d’essere dell’ordinamento del lavoro nelle prime pagine dei manuali e dei trattati di diritto del lavoro, la troviamo immancabilmente individuata nello squilibrio tra domanda e offerta, considerato come dato strutturale del mercato del lavoro. In altre parole, la ragion d’essere del diritto del lavoro sarebbe il difetto della domanda di manodopera rispetto all’offerta: questo squilibrio determinerebbe una strutturale, generalizzata debolezza contrattuale del lavoratore a cui occorre porre rimedio.
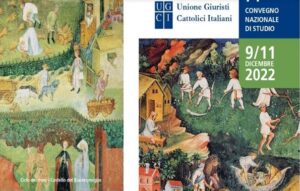 Sennonché da qualche anno noi ci troviamo di fronte a notizie sempre più martellanti nella stampa, nell’informazione quotidiana, che ci raccontano una storia completamente diversa; una storia che impone una riflessione approfondita. Tenterò, nel breve spazio di questa relazione, di dar conto di questo che nel sottotitolo chiamo “il rovesciamento del paradigma del mercato del lavoro”.
Sennonché da qualche anno noi ci troviamo di fronte a notizie sempre più martellanti nella stampa, nell’informazione quotidiana, che ci raccontano una storia completamente diversa; una storia che impone una riflessione approfondita. Tenterò, nel breve spazio di questa relazione, di dar conto di questo che nel sottotitolo chiamo “il rovesciamento del paradigma del mercato del lavoro”.
Ci troviamo di fronte a due fenomeni in parte nuovi che ci impongono una riflessione critica. Il primo: sempre più frequentemente le imprese hanno difficoltà – e, lo vedremo tra breve, difficoltà talvolta gravi – a trovare le persone di cui hanno bisogno.
Secondo fenomeno: la maggior parte delle persone è sempre più capace di scegliere l’azienda in cui lavorare. Di questo abbiamo avuto ultimamente notizia sotto il titolo in lingua inglese “the great resignation”. Si tratta di un fenomeno che riguarda tutti i paesi sviluppati: è bruscamente aumentato il numero delle persone che lasciano volontariamente il proprio lavoro per andare altrove, per fare altro. Il che implica ovviamente che queste persone hanno una possibilità di scegliere.
Questi due fatti mettono in discussione il nostro modo tradizionale di intendere il mercato del lavoro, imponendoci di ripensare il sistema stesso delle tecniche di tutela, perché il sistema di protezione del lavoro nasce in riferimento a un mercato che ha una struttura completamente diversa, quella che gli economisti indicano e studiano con il modello del monopsonio strutturale.
Che cos’è il monopsonio strutturale? È quel mercato in cui c’è un unico compratore di fronte a una grande pluralità di venditori. Nel nostro caso il compratore è l’impresa industriale, che nasce nella prima rivoluzione industriale come una “cattedrale nel deserto”: il deserto della disoccupazione o sottoccupazione agricola, che fa sì che l’imprenditore si trovi di fronte a una platea di offerenti di manodopera privi di potere contrattuale perché non hanno scelta. O le condizioni offerte da lui o lei o la disoccupazione e la miseria.
Questo modello corrisponde a quello che era effettivamente il mercato del lavoro all’indomani della prima rivoluzione industriale. Aveva dunque ragione Karl Marx quando criticava quello che lui indicava come il “diritto borghese”: l’ordinamento che proponeva di rivestire il fenomeno del rapporto di lavoro di una veste contrattuale. Marx diceva: “ma quale contratto? Il contratto di lavoro è la foglia di fico che nasconde la vergogna della dittatura del padrone sull’operaio”. E questa era nella maggior parte dei casi la realtà: basta che leggiamo Zola, Victor Hugo, Dickens, o qualsiasi altro delle condizioni di lavoro e retribuzione degli operai a seguito della prima rivoluzione industriale, nell’800, nella prima metà del 900. Le cose stavano così; ed è in relazione a quel dato strutturale che gli economisti spiegano l’opportunità, la positività da un punto di vista economico di una correzione della distorsione monopsonistica, di quella rendita dell’imprenditore che impoveriva indebitamente il lavoratore.
Ora, però, se le cose stanno nei nuovi termini di cui dicevo all’inizio, o stanno almeno in parte in quei nuovi termini, questo ci impone di guardare al mercato del lavoro con un occhio diverso.
Vi propongo una rassegna molto rapida; ma, credetemi, avrei potuto moltiplicare per venti o per trenta i ritagli di giornali nei quali mi sono imbattuto nel corso di questi ultimi anni e soprattutto di epoca più recente.
“Lavoro: introvabili quattro figure su dieci”. In questa slide vedete la percentuale della difficoltà di reperimento per singole categorie (parliamo di un dato Unioncamere e Anpal del Maggio ’22, pochi mesi fa). Queste sono le categorie dove si trovano le maggiori difficoltà; ma vedete anche che la difficoltà media per tutti i settori era indicata a maggio nel 38,3%, cioè mediamente l’impresa aveva difficoltà a trovare la persona che cercava nel 38% dei casi. Questa situazione che nel linguaggio delle scienze sociali si chiama skill shortage riguarda tutte le categorie produttive e tutti i livelli professionali, non è un fenomeno limitato al lavoro specializzato.
In quest’altra slide vedete ancora una volta selezionate le qualifiche e il tipo di lavoro dove questo fenomeno si verifica con maggiore gravità, addirittura in due casi su tre non si trovano gli operai specializzati del tessile e abbigliamento.
In questa slide abbiamo ancora un dato del maggio ’22, tratto dalla stessa indagine.
 Non è una novità, solo da un anno noi sentiamo parlare della Great Resignation, ma gli osservatori più attenti hanno rilevato questo problema e la sua tendenza alla crescita già da molti anni.
Non è una novità, solo da un anno noi sentiamo parlare della Great Resignation, ma gli osservatori più attenti hanno rilevato questo problema e la sua tendenza alla crescita già da molti anni.
Questo è un ritaglio de La Stampa del marzo 2012, dieci anni fa: “Le aziende cercano personale ma il mercato non ha risposte. Mancano formazione e orientamento”. Perché è chiaro: non è che manchino le persone, non è falso il dato due milioni, due milioni e mezzo, tre milioni di disoccupati in Italia, che ci è stato fornito negli ultimi anni. Quel dato è vero. Il problema è che quelle persone non hanno a disposizione un percorso di formazione o addestramento che le conduca a rispondere alla domanda che nel tessuto produttivo si esprime.
E, osservate, questo fenomeno si verifica anche nel cuore delle crisi economiche, nei punti bassi della congiuntura. In questa slide vedete il titolo del Sole 24 Ore del 2 febbraio 2020: eravamo nell’occhio del ciclone della peggiore recessione degli ultimi decenni. Eppure, “Il 30% dei posti di lavoro è vacante”! Siamo nel punto peggiore della recessione, eppure un posto su tre non si riesce a coprire, perché le imprese non trovano le persone di cui avrebbero bisogno. “Introvabili 355.000 profili professionali. La mancata corrispondenza tra domanda e offerta sul mercato del lavoro denunciata a più riprese dalle imprese incomincia ad assumere dimensioni preoccupanti”…
In realtà ha cominciato già da tempo! E il fenomeno sembra addirittura accentuarsi, paradossalmente, nella congiuntura negativa. Siamo abituati a pensare che nella congiuntura negativa sia più facile trovare manodopera; invece sembra che sia vero addirittura il contrario. Guardate: questa è una notizia del 15 Ottobre, siamo a due mesi fa: “Assunzioni giù del 26,5%” – è incominciata la fase recessiva ma – “in un caso su due” (è un arrotondamento: Unioncamere e Anpal dicono nel 45% dei casi) “le imprese non trovano le giuste competenze”
Il fenomeno è aumentato di 9 punti nel 2021: l’anno scorso si è dunque registrato un pesante aggravamento. E ormai il dato è riportato su tutti i giornali. Questo è Il Corriere della Sera del 5 dicembre, la settimana scorsa: “Il lavoro c’è, ma non ci sono i lavoratori adatti”. La domanda di lavoro c’è, e anche tanta; sono i lavoratori – specializzati e non solo – che mancano.
Se ne parla poco; eppure anche questo è un fattore di crisi. Quanto ci costa in termini di mancata crescita e/o di resistenza alla recessione che verrà?. Tenete conto che quella stessa indagine, che è un’indagine permanente Anpal-Unioncamere denominata “Excelsior”, quantifica in un milione e duecentomila i posti di lavoro che restano permanentemente scoperti perché le imprese non trovano la persona adatta a ricoprirli. Ora, se considerate che la nostra disoccupazione oscilla fra i due milioni e mezzo e i tre milioni – e siamo al 9% di disoccupazione rispetto alla forza lavoro complessiva – vi rendete conto che se noi fossimo in grado di costruire i percorsi che portano dalla situazione della persona in cerca di lavoro a ciò che il tessuto produttivo richiede, noi potremmo dimezzare la nostra disoccupazione riportandola al di sotto di quel 5% che è considerato dagli economisti di tutto il mondo come la soglia della disoccupazione fisiologica, al di sotto della quale la disoccupazione è solo un fatto di attrito, è un problema frizionale ma non una patologia come è invece quando il tasso supera il 5%, e tocca il 7 o il 9%.
Abbiamo visto, poi, che il problema si pone a tutti i livelli: quindi non si tratta di far prendere a un disoccupato la laurea in chirurgia o in elettronica; si tratta di attivare un corso di formazione che può anche essere di tre mesi, quattro mesi, sei mesi, un anno. Ma se noi fossimo in grado di costruire questo percorso per ciascuno dei posti di lavoro rispetto ai quali si verificano queste situazioni di skill shortage, avremmo eliminato la parte patologica della disoccupazione, avremmo rimesso il mercato del lavoro in equilibrio.
Arriviamo così ai giorni nostri, con la Great Resignation. In questa slide vi propongo i dati di uno studio recente che mostra come il fenomeno in Italia rispecchi ciò il fenomeno che è stato denunciato inizialmente soprattutto in relazione agli USA. Accade anche in Italia. Anche qui sono in significativa crescita le dimissioni: +15%-20% oggi rispetto al ’19. I lavoratori trovano lavoro più rapidamente; se aumentano le dimissioni è perché la gente ha più facilità a trovare un nuovo lavoro. I lavoratori si spostano più frequentemente a un altro settore, a un altro contenuto professionale. Dunque – questo è il dato nuovo con cui dobbiamo fare i conti – hanno una possibilità di scelta.
Il mercato del lavoro si caratterizza sempre di più come “mercato transizionale”, cioè come un mercato nel quale la persona non resta ingabbiata nella posizione che assume al suo ingresso nel tessuto produttivo: è normale, è usuale che la posizione cambi, che la persona esca da un settore, esca dal singolo mestiere, cambi attività, si sposti, si muova. Perché questo è oggi molto più possibile di quanto non fosse in passato.
La mobilità è nettamente aumentata.
Badate: ancora una volta, questa è solo la punta che ha colpito l’immaginazione dei cronisti, per cui adesso se ne parla sui giornali e in televisione; ma se voi andate a prendervi il libro sulla mobilità del lavoro di Bruno Contini del 2005 trovate indicati in nuce questi fenomeni già allora. Bruno Contini nel 2005 diceva “attenzione, perché la mobilità spontanea in Italia è tra il 25% e il 30%. Qui ora siamo a livelli superiori; ma già allora c’era una persona su quattro o su tre che si dimetteva e andava altrove perché era in grado di scegliere.
Ecco perché dico che occorre rovesciare il paradigma del mercato del lavoro: perché esso non può più essere considerato, concepito, studiato soltanto come mercato “del lavoro”, cioè come luogo dove è solo l’imprenditore a scegliersi i propri collaboratori, ma è anche in larga parte un mercato “dell’imprenditoria”. Cioè un luogo in cui sono i lavoratori a scegliersi l’impresa che meglio può valorizzare il loro lavoro. Non è solo l’imprenditore che sceglie ma in molte situazioni sono anche i lavoratori a scegliere e ingaggiare l’imprenditore e questa è una nozione sorprendente, una nozione che impone un modo nuovo di guardare ai problemi del mercato del lavoro.
A questo tema ho dedicato un libro uscito nel 2020, due anni e mezzo fa, nel quale mi propongo di mostrare come questa scelta dell’imprenditore non sia compiuta solo al livello individuale, ma sia talvolta anche una scelta compiuta al livello collettivo. I lavoratori delle aziende in crisi hanno sovente la possibilità di scegliersi l’imprenditore. Vicende come quelle di Alitalia nel 2008, nella quale i lavoratori esaminano la proposta di Air France- KLM, la bocciano, scelgono un’altra cordata di imprenditori; poi nel ’17 valutano e decidono su un piano industriale di Etihad; ma anche come la vicenda della Fiat, dove i lavoratori nel 2010 sostanzialmente scelgono – sì, sono proprio loro a scegliere con il referendum del giugno di quell’anno – tra la prospettiva della nazionalizzazione dell’impresa, cioè dello Stato imprenditore, e il piano industriale proposto da Sergio Marchionne; e molte altre vicende che ho proposto in quel libro mostrano come la scelta dell’imprenditore, talvolta, sia anche una scelta collettiva.
Ma io non posso adesso dedicare neanche un minuto in più a questo aspetto: qui devo concentrarmi sulla scelta individuale, sulla scelta dell’imprenditore da parte del singolo lavoratore.
Questa scelta è ben visibile quando una persona decide, per esempio, se cercar lavoro nel settore pubblico o nel settore privato; se nel privato, in quale settore produttivo, se in una azienda piccola o in una grande. E dove: se vicino a casa o altrove. La mobilità e il conseguente aumento del raggio di azione sono fattori di aumento della possibilità di scelta delle persone. Naturalmente la persona ha questa possibilità se ha l’informazione e la disponibilità del percorso di formazione che le consente di candidarsi al posto di lavoro a cui aspira.
Questo è un concetto che a noi giuristi non è familiare: noi siamo abituati a parlare di diritto, quindi di una norma che, se è scritta nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere applicata dal giudice; se dunque la norma dice che uno ha un certo diritto, il giudice assicurerà l’attuazione di quel diritto. Ma nel mercato del lavoro le cose per lo più non vanno così: la norma non basta.
Permettetemi, a questo proposito, di rendere omaggio a un carissimo collega giuslavorista, che è mancato nei giorni scorsi: Riccardo Del Punta. Uno dei contributi maggiori che Riccardo Del Punta ha dato alla cultura del lavoro, delle relazioni industriali, sta nell’aver fatto rifluire nella nostra cultura di giuristi l’approccio che va sotto il nome di capability approach proposto, studiato e approfondito soprattutto da Amartya Sen. Che cos’è il capability approach? è l’impostazione che sottolinea come non basti la norma, il principio di diritto, per attribuire alla persona il bene della vita individuato, ma occorre tutto un sistema di empowerment, un insieme di strumenti volto a rendere effettivo l’esercizio del diritto. Ecco, io oggi voglio proporvi questo approccio proprio in riferimento al tema che stiamo esaminando. La possibilità effettiva: quindi non la norma in Gazzetta Ufficiale, ma gli strumenti che danno la capability. La capacità effettiva di esercitare la scelta nel mercato del lavoro deve essere data a tutti, perché noi fin qui abbiamo parlato di una metà soltanto della forza lavoro, quella che ha la possibilità di scelta, quella che ha il bivio di fronte a sé, può scegliere tra questa e quella impresa; ma non tutti i lavoratori hanno questa possibilità.
L’idea che tutti debbano poter scegliere nel mercato del lavoro, cioè debbano essere messi in condizione di optare tra una possibilità di lavoro e un’altra per scegliere quella che ritengono migliore, non è un’utopia; è detto nell’articolo 4 della Costituzione. Dove si legge che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Vedete come il capability approach sia già presente in questa norma costituzionale! La quale aggiunge che ogni cittadino deve poter “esercitare questo diritto secondo le proprie possibilità e la propria scelta”.
Vedete dunque come l’idea di quel rovesciamento del paradigma del mercato del lavoro di cui parlavo all’inizio fosse già presente nella Costituzione: l’idea che tutti abbiano un diritto protetto dalla Costituzione a poter scegliere il proprio lavoro, quindi a non essere in condizione di inferiorità nei confronti della controparte padronale. È uno dei diritti fondamentali, uno dei primi diritti indicati dalla Costituzione.
Ora, qual è il modo in cui si rende effettivo questo diritto? Occorre assicurare alle persone le necessarie informazione, formazione efficace (torniamo su questo punto in chiusura, nell’ultima parte di questa mia relazione) e mobilità.
In Scandinavia, in particolare in Svezia, i servizi per l’impiego si occupano di assistere le persone per incrementarne la mobilità, perché è dimostrato che la possibilità di scelta, quindi il potere contrattuale, aumentano in ragione quadratica – cioè secondo una funzione esponenziale – rispetto al raggio di mobilità della persona.
Naturalmente oltre a questo occorre anche promuovere la più ampia possibile pluralità di imprese in concorrenza tra loro sul lato della domanda; e questo è un tema di politica industriale che, ovviamente, noi qui non affrontiamo; ma è doveroso almeno menzionarlo.
Il nocciolo della questione dell’empowerment, del capability approach, è la nozione di formazione efficace. Ricordo qui quella che fu un’intuizione importantissima di Bruno Trentin – ricordate? Fu Segretario generale prima della Fiom-Cgil, poi della Confederazione stessa – il quale, pensate, nei primi anni ’90 già parla del diritto alla formazione permanente efficace come protezione fondamentale del lavoro nell’era dell’economia digitale e della globalizzazione. Già dieci anni prima dei grandi scontri sull’art. 18 Bruno Trentin diceva “guardate che la protezione fondamentale è la formazione efficace.
Dobbiamo dunque interrogarci su cosa sia la formazione efficace e come la si garantisca. Quell’intuizione sul piano sindacale ha avuto un principio di attuazione con i contratti collettivi metalmeccanico, chimico e bancario, che hanno previsto un diritto alla formazione continua; ma lo hanno previsto in una misura ridottissima. E soprattutto è mancato, in questi contratti collettivi, il controllo sull’efficacia della formazione. Perché la formazione che serve per l’empowerment della persona è solo quella di cui si conosce la qualità e l’idoneità a rispondere a ciò che il tessuto produttivo richiede.
Che cosa garantisce che la formazione sia efficace? Occorre un monitoraggio permanente e capillare del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi. Questo monitoraggio permanente è possibile, ed è sperimentato in numerosi Paesi attraverso uno strumento molto facilmente comprensibile nella sua natura e funzionamento: un’anagrafe della formazione. Esattamente come abbiamo un’anagrafe scolastica, allo stesso modo occorrerebbe un’anagrafe di tutti i frequentatori di corsi di formazione finanziati col denaro pubblico, i cui dati dovrebbero essere incrociati con le comunicazioni al Ministero del Lavoro sui contratti di lavoro che vengono via via stipulati, ma anche agli albi di mestieri, di professioni e anche le iscrizioni alle liste di disoccupazione, lungo tutta la vita della persona. Se realizzassimo questo incrocio tra i dati dell’anagrafe della formazione e i dati su ciò che accade alla persona nel mercato del lavoro noi avremmo di ogni corso l’esatta misura dell’efficacia: cioè quando e quanto quel corso abbia prodotto risultati occupazionali.
Naturalmente questo dato, che si chiama “tasso di efficacia”, “tasso di coerenza” tra sbocchi occupazionali e formazione impartita, dovrebbe essere obbligatoriamente pubblicato per ogni centro di formazione professionale.
Questo dato è indispensabile per il servizio di orientamento scolastico e professionale. Nei paesi dove il guidance service funziona chi lo esercita, il job advisor ha questo come materia prima, o se preferiamo come strumento di lavoro: la possibilità di dire innanzitutto a ogni adolescente all’uscita di ogni ciclo scolastico (ma anche alla persona adulta che intende cambiare lavoro o ha perso il lavoro e ne deve trovare un altro): “guarda, questo corso in tre mesi ti porta a fare l’antennista di cui c’è gran bisogno e hai un’ottima probabilità di ottenere il posto perché il corso ha un tasso di coerenza dell’80-90%; in sei mesi puoi andare invece a fare quest’altra cosa; se vuoi invece investire di più, in 12 o in 24 mesi puoi fare quest’altro percorso, più ambizioso, nel quale ti assistiamo, ti appoggiamo, ti retribuiamo”. Perché la Cassa integrazione, il Reddito di cittadinanza, la Naspi, il trattamento di disoccupazione sono tutte forme con cui si può retribuire chi sceglie di compiere un percorso di formazione e riqualificazione.
È quello di cui parlava il Prof. Bellomo poco fa.
Ma per fare questo occorre che si conosca il tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi; e che poi si attivi la condizionalità, cioè che i servizi per l’impiego svolgano effettivamente la funzione di proporre i percorsi di transizione alla nuova occupazione; ma al tempo stesso di condizionare il godimento del sostegno del reddito alla scelta effettiva di un percorso da parte della persona interessata.
Senonché questo dato – il tasso di efficacia della formazione – in Italia non è disponibile. Quando noi parliamo di “servizio di orientamento scolastico e professionale” parliamo di qualcosa di incomparabilmente meno sviluppato e sofisticato di quello che funziona nei Paesi del centro e nord Europa, dove ogni adolescente, all’uscita da ogni ciclo scolastico, è raggiunto capillarmente e in modo efficace di questo servizio.
Concludo osservando che questo meccanismo di rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali era previsto nel Decreto legislativo numero 150 del 2015, uno degli otto decreti attuativi del Jobs Act, agli artt. 13, 14, 15, 16. Che prevedeva esattamente questo. La previsione normativa, trattandosi di materia di competenza delle Regioni, è stata emanata previa intesa tra Stato e Regioni in sede di conferenza Stato-Regioni: tutte le Regioni, dunque, avevano prestato il loro consenso. Altrimenti la norma non avrebbe potuto essere emanata in una legge dello Stato. Dopodiché il referendum sulla riforma costituzionale è andato come è andato, tutta l’ipotesi politica che era stata coltivata fino a quel momento è venuta meno; e queste norme – che però sono pur sempre norme dello Stato, sono norme in vigore – sono rimaste lettera morta: non c’è una Regione che abbia realizzato questo meccanismo.
Cosa si può fare subito? Beh, io dico che nulla vieta che ciascuna Regione faccia ciò che quella legge diceva e tuttora dice. Qui a Roma, nel Lazio abbiamo un appuntamento elettorale a febbraio; a casa mia, a Milano, ce n’è un altro analogo; questo tema dovrebbe essere al centro della campagna elettorale sia qui sia lì. Invece nessuno ne parla.
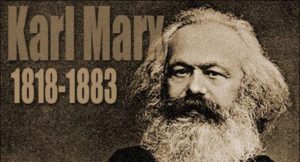 Per concludere e riassumere: il modello economico che rappresenta meglio i caratteri strutturali del mercato del lavoro oggi in Italia non è più il monopsonio strutturale di cui abbiamo parlato all’inizio, quello a cui si riferiva il Marx, quello della “foglia di fico che nasconde la vergogna della dittatura del padrone sull’operaio”, bensì semmai un monopsonio dinamico, cioè un mercato nel quale la distorsione nasce non da un difetto della quantità complessiva della domanda rispetto alla quantità complessiva dell’offerta, ma da un difetto di informazione, di formazione efficace e di assistenza alla mobilità delle persone, difetto di servizi al mercato del lavoro, difetto di politiche attive, difetto di strumenti di empowerment, difetto di quel capability approach di cui ho parlato prima, che è cosa nuova e diversa rispetto a quello di cui noi giuristi ci siamo prevalentemente occupati nel passato recente e remoto.
Per concludere e riassumere: il modello economico che rappresenta meglio i caratteri strutturali del mercato del lavoro oggi in Italia non è più il monopsonio strutturale di cui abbiamo parlato all’inizio, quello a cui si riferiva il Marx, quello della “foglia di fico che nasconde la vergogna della dittatura del padrone sull’operaio”, bensì semmai un monopsonio dinamico, cioè un mercato nel quale la distorsione nasce non da un difetto della quantità complessiva della domanda rispetto alla quantità complessiva dell’offerta, ma da un difetto di informazione, di formazione efficace e di assistenza alla mobilità delle persone, difetto di servizi al mercato del lavoro, difetto di politiche attive, difetto di strumenti di empowerment, difetto di quel capability approach di cui ho parlato prima, che è cosa nuova e diversa rispetto a quello di cui noi giuristi ci siamo prevalentemente occupati nel passato recente e remoto.


