Gli anni ’70 segnarono una discontinuità netta sia nelle relazioni industriali nazionali, sia negli equilibri aziendali; tra i mutamenti più rilevanti vanno annoverati quelli relativi al rapporto di fatto tra datore e prestatore in occasione della malattia e alla relativa disciplina, che assunsero anche coloriture fortemente politiche
.
Intervista a cura di Silvia Caneve, pubblicata sul Bollettino Adapt il 4 dicembre 2023 – L’intervista è parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei miei scritti pubblicati nell’arco degli ultimi 50 anni; questa prende spunto dal mio articolo Malattia, assenteismo e giustificato motivo di licenziamento, pubblicato in Rivista giuridica del lavoro, 1976, n. 3, I, pp. 259-281 – Su questo sito sono disponibili anche le due interviste precedenti della stessa serie, rispettivamente sul tema Il mercato del tempo di lavoro e La partecipazione dei lavoratori nell’azienda
.
 Nell’introduzione della raccolta Noterelle. Diario di un ventennio, racconti del tuo primo incontro con il professor Giuseppe Pera, il quale fu colpito dal coraggio dimostrato da un giovane sindacalista della Cgil che scrisse della necessità di combattere l’assenteismo abusivo. Da questo punto di vista, all’epoca, il tuo saggio rappresentò un punto di rottura rispetto ad alcuni orientamenti e tesi sostenute dal sindacato. Cosa ti spinse ad indagare il tema dell’assenteismo? E cosa avevi colto in quel fenomeno e nella disciplina del licenziamento per malattia, che non emergeva dal dibattito di quegli anni?
Nell’introduzione della raccolta Noterelle. Diario di un ventennio, racconti del tuo primo incontro con il professor Giuseppe Pera, il quale fu colpito dal coraggio dimostrato da un giovane sindacalista della Cgil che scrisse della necessità di combattere l’assenteismo abusivo. Da questo punto di vista, all’epoca, il tuo saggio rappresentò un punto di rottura rispetto ad alcuni orientamenti e tesi sostenute dal sindacato. Cosa ti spinse ad indagare il tema dell’assenteismo? E cosa avevi colto in quel fenomeno e nella disciplina del licenziamento per malattia, che non emergeva dal dibattito di quegli anni?
La cosa andò così. Nella prima metà degli anni ’70 si era assistito, nelle aziende di tutti i settori, a un notevole aumento dei tassi di assenza per malattia; era aumentata soprattutto la frequenza delle assenze brevi, accompagnata dalla teorizzazione, da parte di alcuni gruppi di estrema sinistra, dell’astensione dal lavoro come forma di lotta, come una sorta di sciopero individuale. Ovviamente numerose imprese avevano reagito con sanzioni disciplinari, che arrivavano anche al licenziamento; e in seno al movimento sindacale si discuteva sul come dovesse interpretarsi il fenomeno e se si dovessero difendere anche gli assenteisti abusivi. Dall’inizio del 1974 ero il responsabile del Coordinamento dei Servizi Legali della Camera del Lavoro di Milano; e tenevo un incontro mensile degli addetti alle vertenze dei vari sindacati di categoria, aperto a tutti i membri di Consigli di Fabbrica che desiderassero parteciparvi: era inevitabile che uno di quegli incontri fosse dedicato a questo tema scottante. Per quell’incontro preparai una scheda, approvata dalla Segreteria della Camera del Lavoro e pubblicata nel suo bollettino Documentazione camerale, nella quale sostenevo che doveva essere considerato come un fenomeno positivo e legittimo l’aumento delle assenze conseguente a un allargamento effettivo della possibilità di curarsi, ma che – proprio per la difesa di questo diritto – dovesse essere respinta l’idea dell’abuso della malattia come forma di lotta operaia contro il padrone. Su questa mia presa di posizione si scatenò un dibattito molto vivace.
E tu scrivesti Malattia, assenteismo e giustificato motivo di licenziamento.
Carlo Smuraglia, che mi aveva preso da poco come assistente alla Statale, mi invitò ad approfondire il tema sul piano giuridico. Ma mi accorsi subito che la questione non poteva essere affrontata soltanto sul piano astratto e rarefatto dell’interpretazione della norma legislativa. In quegli anni non c’era stata soltanto la novità dell’entrata in vigore dell’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, ma anche quella di numerosi contratti collettivi nazionali che – a seguito della tornata di rinnovi del 1972 – introducevano il diritto dei lavoratori al pagamento della retribuzione per i primi tre giorni di malattia (i c.d. “giorni di carenza”), non coperti dall’indennità pagata dall’Inps. Né la nuova norma legislativa né queste nuove disposizioni contrattuali intervenivano a modificare la nozione teorica di “malattia” come giustificazione dell’astensione dal lavoro; ma era evidente che il nuovo contesto determinava un allargamento della possibilità di fatto, per i lavoratori, di sospendere la prestazione per malattia. Si trattava dunque di discernere quanta parte di questo allargamento corrispondesse a un’evoluzione dell’intero ordinamento del lavoro e quanta parte invece dovesse qualificarsi come abuso. Per prima cosa mi convinsi che fosse necessario studiare la correlazione tra l’aumento delle assenze brevi e l’introduzione del diritto alla retribuzione per i giorni di “carenza”; e – anche se allora non erano disponibili gli strumenti di analisi statistica del nesso causale tra due fenomeni, che sono in uso oggi – almeno una forte correlazione balzò fuori con una nettezza impressionante. A me parve ragionevole dedurne che nei contratti collettivi da poco rinnovati si esprimesse una volontà delle parti firmatarie – non soltanto di migliorare il trattamento economico, ma anche – di allargare l’area della malattia idonea a giustificare l’astensione dal lavoro; il che però non giustificava l’abuso.
Così tu sperimentasti sul campo per un verso una coniugazione dell’analisi sociologica di tipo quantitativo con l’argomentazione giuridica, per altro verso la valorizzazione della contrattazione collettiva come fonte del diritto del lavoro: direttamente in linea con la predicazione di Gino Giugni. Eri già in contatto con lui?
Sì, anche se a quell’epoca non un contatto stretto. Lo avevo conosciuto in modo un po’ rocambolesco nel 1974, quando avevo portato il plico contenente la mia tesi di laurea alla sede romana della Fondazione Brodolini, in via Livenza 5, per partecipare al concorso per una borsa di studio; lì ero stato ricevuto molto cordialmente da un signore, che mi aveva interrogato su quanto stava accadendo alla Statale di Milano per la successione sulla cattedra di Diritto del Lavoro, a seguito del pensionamento della professoressa Luisa Riva Sanseverino. Io gli avevo risposto che noi giovani facevamo il tifo per la candidatura di Gino Giugni, ma che il preside Cesare Grassetti e la maggioranza della Facoltà non lo apprezzava, considerandolo troppo “sociologo” e troppo poco rigoroso giurista; per fortuna aggiunsi che, invece, noi giovani assistenti facevamo il tifo per quest’ultimo. Solo al termine del colloquio lui mi disse ridendo che il candidato di cui stavo parlando era proprio lui. Si divertì molto della mia ingenuità. In seguito, però, lesse e apprezzò la mia tesi di laurea sul contratto collettivo aziendale, che all’epoca era ancora un tema nuovo per il nostro diritto sindacale; e, cosa insolita nei rapporti tra un cattedratico e un giovanissimo “nessuno” qual ero, mi scrisse di quel suo apprezzamento.
Come reagirono l’establishment giuslavoristico e quello sindacale al tuo saggio su malattia e assenteismo?
A Carlo Smuraglia, che pure non condivideva proprio tutto ciò che sostenevo, il mio lavoro piacque, al punto che ne propose la pubblicazione sulla Rivista giuridica del lavoro, organo trimestrale della Cgil nazionale, della cui Direzione faceva parte. Ma anche la segreteria della Cgil milanese, in particolare il segretario generale Lucio De Carlini e Carletto Gerli, lo apprezzarono e mi confermarono l’indicazione di proseguire su quella linea il lavoro di coordinamento del settore vertenze e dell’azione in giudizio degli avvocati. Era una Cgil diversa dall’attuale.
Nel saggio tu sostieni che l’aumento del tasso delle assenze che si registrava negli anni Settanta era una tendenza comune a tutti i Paesi occidentali: i lavoratori, una volta posti nella possibilità effettiva e giuridica di farlo, iniziavano a curare maggiormente la propria sfera personale. Il fenomeno rappresentò dunque la rivendicazione di un bisogno più che una strategia per «mettere in crisi gli assetti economico-sociali costituiti», come invece molti imprenditori sostenevano.
Gli imprenditori si sentivano le mani legate dallo Statuto dei Lavoratori e tendevano a considerare l’intero fenomeno dell’aumento del tasso delle assenze come manifestazione di un abuso dilagante. A questo modo di vedere la cosa rispondevo ponendo in evidenza quattro fenomeni concomitanti: la riforma della disciplina legislativa dei controlli ispettivi, che limitava, sì, la possibilità per gli imprenditori di contrastare gli abusi, ma limitava di fatto anche la possibilità per loro di comprimere indebitamente l’esercizio del diritto dei dipendenti a curarsi, ciò che in precedenza era diffusamente accaduto; un nuovo assetto della disciplina collettiva della materia che eliminava (o dimezzava, come nel caso del contratto per il settore tessile) il disincentivo economico alle assenze brevi costituito dalla “carenza” della retribuzione per i primi tre giorni di malattia; una effettiva maggiore libertà di fatto per i lavoratori di astenersi dal lavoro per infermità di breve durata, conseguente anche al mutamento dei rapporti di potere in azienda; il diffondersi, nella parte più ideologizzata del movimento sindacale della parola d’ordine dell’astensione dal lavoro come forma di lotta individuale contro il sistema. E mi proponevo di fondare su di una considerazione sistemica di questi quattro fenomeni un ragionamento giuridico equilibrato.
In quella reazione datoriale vedevi più una incomprensione di questa dinamica complessa, o più una strumentalizzazione del fenomeno dell’assenteismo finalizzata a ripristinare lo status quo ante e ottenere una maggiore governabilità delle fabbriche?
Erano presenti entrambe le tendenze. E a entrambe occorreva rispondere con un ragionamento il più possibile sereno e non fazioso. Il vagheggiamento di un ritorno allo status quo ante era sicuramente irragionevole; non era neppure condiviso, del resto, dalla maggior parte del mondo imprenditoriale. Ma la preoccupazione degli imprenditori per l’assenteismo abusivo e per un eccesso di tolleranza di una parte dei giudici del lavoro nei suoi confronti aveva anche il suo buon fondamento. E al sindacato confederale va riconosciuto il merito di avere, in quell’occasione, assunto una posizione molto responsabile.
Vedi delle analogie tra gli eccessi che si verificarono allora e quanto accade oggi nel sistema delle relazioni industriali e nel dibattito giuslavoristico, in particolare per quel che riguarda sia la diffusione di tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo pieno e indeterminato, sia le tutele contro il licenziamento illegittimo?
Qualche analogia si può, certo, individuare; ma i due contesti sono profondamente diversi. Allora si assisteva a un movimento sindacale fortemente egemonizzato dalle tre confederazioni maggiori, che voltava tumultuosamente pagina rispetto a un quarto di secolo nel quale gli imprenditori si erano trovati in una posizione di strapotere nei confronti dei propri dipendenti; oggi assistiamo a un fronte sindacale sempre più frammentato e incapace di dettare l’agenda del sistema delle relazioni industriali, in alcuni settori incapace persino di combattere efficacemente la povertà lavorativa, che si contrappone ad associazioni imprenditoriali prive di visione innovativa e di progettualità, forse rassegnate a un progressivo deterioramento dell’efficienza del sistema delle relazioni industriali.
Nel saggio del 1976 sottolinei come, dopo l’approvazione dello Statuto dei lavoratori, siano state le parti sociali, direttamente o indirettamente, a ricoprire un ruolo cruciale nell’ampliamento della «libertà di ammalarsi». Evidenzi, inoltre, come l’assenteismo fosse un problema da risolvere proprio attraverso lo strumento della contrattazione collettiva. Negli anni le parti sociali hanno adottato diverse strategie per disincentivare l’assenteismo, dall’incidenza del numero di assenze sul calcolo del premio di risultato alla progressiva diminuzione del trattamento economico, al superamento di un certo numero di assenze di breve durata. Ritieni che questo tipo di previsioni contrattuali incidano o abbiano inciso sui comportamenti dei lavoratori?
 Sì. Se si esclude il contratto Fiat del 2010, non è stata quasi mai rimessa in discussione la retribuzione per i primi tre giorni di malattia, che invece avrebbe potuto essere rimodulata in funzione di contrasto all’abuso delle assenze brevi; però sono stati introdotti i correttivi che hai menzionato, che sostanzialmente rimodulano il contenuto assicurativo del contratto rispetto al rischio-malattia, configurando in vario modo un disincentivo all’abuso.
Sì. Se si esclude il contratto Fiat del 2010, non è stata quasi mai rimessa in discussione la retribuzione per i primi tre giorni di malattia, che invece avrebbe potuto essere rimodulata in funzione di contrasto all’abuso delle assenze brevi; però sono stati introdotti i correttivi che hai menzionato, che sostanzialmente rimodulano il contenuto assicurativo del contratto rispetto al rischio-malattia, configurando in vario modo un disincentivo all’abuso.
L’articolo 2110 c.c. opera la traslazione del rischio inerente all’infermità dal lavoratore al datore di lavoro e delega per lo più alla contrattazione collettiva il compito di individuare un termine alla durata di questa tutela. La Cassazione, recependo orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha di recente giudicato discriminatoria la previsione, all’interno di un contratto collettivo, di un periodo di comporto indifferenziato che non tenga conto della disabilità, categoria all’interno della quale, a questi fini, viene fatta rientrare a certe condizioni anche la malattia cronica. Ritieni che la traslazione del rischio operata dall’articolo 2110 c.c. possa essere oggi meglio perseguita dalle previsioni dei contratti collettivi? E più in generale: le parti sociali, a tuo parere, si fanno adeguatamente carico della gestione delle problematiche di salute di una forza lavoro che, anche a causa della trasformazione demografica in atto e dell’allungamento delle carriere, sarà sempre più caratterizzata da condizioni psico-fisiche non ottimali?
La previsione di un termine di comporto differenziato per i casi di malattia cronica, in particolare di malattia oncologica o neurodegenerativa, secondo l’indicazione proveniente dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo e dalla nostra Cassazione, è ormai recepita in numerosi contratti collettivi. Disposizioni analoghe possono utilmente essere introdotte nei contratti a favore delle persone anziane o comunque più esposte al rischio di infermità, anche di breve durata. Ma almeno nel caso citato sopra del contratto Fiat del 2010 la contrattazione collettiva è stata recettiva anche nei confronti di sollecitazioni di segno opposto.
A che cosa ti riferisci?
Il contratto Fiat del 2010 limitò il pagamento della “carenza” nei casi di picchi di assenze brevi coincidenti con eventi sportivi di grande richiamo, o con altre cause tipiche di assenteismo abusivo. Ebbi poi conferma da un protagonista di quella vicenda del fatto che l’idea di quella disposizione aveva tratto spunto dalla proposta – contenuta nel mio libro A che cosa serve il sindacato, la cui prima edizione è del 2005 – di un possibile scambio contrattato al livello aziendale tra riduzione della retribuzione per i giorni di “carenza” e aumento retributivo in forma di superminimo aziendale: un’operazione suscettibile di penalizzare solo i “malati del lunedì”, senza costi e anzi con un vantaggio economico netto per chi ha un tasso di assenze brevi nella norma. È, in sostanza, lo stesso meccanismo che nelle polizze assicurative viene chiamato “franchigia”, e che si applica di regola in Gran Bretagna, dove i primi tre giorni di assenza non devono essere coperti da certificato medico, salvo che la malattia si protragga più a lungo, ma vengono retribuiti solo in questo caso.
Nonostante le molteplici conquiste, l’esigenza dei lavoratori, emergente fin dagli anni Settanta, di trovare un giusto equilibrio tra la dimensione lavorativa e la propria sfera personale pare non essere ancora stata soddisfatta. Soprattutto dopo l’esperienza pandemica, sulle pagine dei giornali vengono trattate quotidianamente questioni legate al benessere e alla serenità mentale dei lavoratori: sempre più spesso viene menzionata l’importanza dell’implementazione delle misure di flessibilità oraria in favore dei lavoratori e di work-life balance, quali strategie per trattenere soprattutto le risorse più qualificate. Quali politiche e strumenti potrebbero adottare, nella diversità dei rispettivi ruoli, il legislatore e le parti sociali in relazione a questo problema?
Nella situazione che è venuta a crearsi in Italia – riscontrabile, peraltro, in qualche misura anche in tutti gli altri Paesi europei – di difficoltà per le imprese nel reperimento delle persone che cercano, in tutte le fasce professionali, le imprese stesse devono competere tra loro non solo sul piano dei livelli di retribuzione offerti, ma anche su quello del benessere delle persone dentro e fuori dell’ambiente di lavoro. In questa competizione vince l’impresa che riesce a trovare le soluzioni più efficaci per la conciliazione del tempo di lavoro e il tempo di cura familiare, a offrire ai propri dipendenti la migliore conciliazione tra le esigenze di elasticità e flessibilità del tempo di lavoro nell’interesse dell’organizzazione aziendale e le esigenze di elasticità e flessibilità del tempo di lavoro nell’interesse di ciascun lavoratore. In questo ordine di idee il lavoro agile in tutte le sue molte forme aggiunge un’opzione di importanza cruciale in tema di politiche di conciliazione; ed è desinato a incidere profondamente sulle organizzazioni aziendali, così come sull’organizzazione di molte famiglie.
Nel tuo saggio del 1976 hai anticipato la tesi, che avresti poi esposto in modo organico nella voce Malattia del lavoratore per l’Enciclopedia giuridica Treccani, secondo cui l’infermità costituisce un caso non di impossibilità della prestazione, bensì di inesigibilità. Quali sono i profili di rilevanza pratica di questa diversa qualificazione della causa di sospensione del lavoro?
In primo luogo, soltanto in un quadro di inesigibilità può spiegarsi la vistosa incongruenza tra l’estensione del concetto medico di “infermità” e quella del concetto giuslavoristico di “astensione dal lavoro per motivi di salute”: quest’ultimo è, per un verso, molto più esteso rispetto al primo, dal momento che comprende anche i periodi di convalescenza e le astensioni dal lavoro necessarie per sottoporsi a visite mediche di controllo, oppure a profilassi di malattie possibili ma non attuali; per altro verso, il concetto giuslavoristico è meno esteso rispetto a quello medico, poiché non comprende il grande novero delle infermità non in fase di acuzie, le quali non possono giustificare l’astensione dal lavoro: si pensi per esempio alla miopia, al deficit uditivo, alla carie dentaria, alla scoliosi, alle varie possibili forme di reumatismi, e così via. Inoltre, solo se si ragiona in termini di inesigibilità, non se si applica la categoria dell’impossibilità, si riesce a spiegare l’esistenza di un’area amplissima nella quale l’infermità legittima chi ne soffre ad astenersi dal lavoro, ma non lo obbliga a farlo: si pensi alla leggera bronchite, all’emicrania di entità media, alla gastrite, alla distorsione di una caviglia, e l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo.
Quali consigli daresti, dal punto di vista metodologico, a giovani studiosi che si accingono ad affrontare oggi fenomeni sociali complessi come l’assenteismo, che possono forse essere compresi solo attraverso una prospettiva interdisciplinare e un’analisi condotta in molteplici campi del sapere, tra cui anche il diritto delle relazioni industriali?
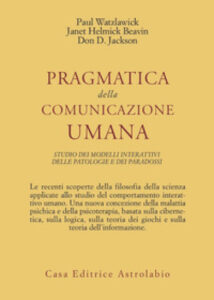 Consiglierei loro, innanzitutto, due libri che per me sono stati fondamentali: uno è il libro di Elton Mayo di cui fra dieci anni si celebrerà il centenario della pubblicazione, I problemi umani e socio-politici della civiltà industriale; l’altro è il libro di Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin e Don D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, sul quale dalla fine degli anni ’60 si è fondata la c.d. “scuola sistemica”, fondata sull’idea che nessun comportamento umano può essere capito e spiegato se non come reazione al comportamento delle altre persone con cui esso interagisce. A ben vedere Elton Mayo lo intuisce e applica questo criterio di lettura, nello studio dei comportamenti nel luogo di lavoro, con trent’anni di anticipo rispetto alla esposizione compiuta della teoria sistemica da parte di Paul Watzlawick. L’approccio sistemico a me sembra assolutamente indispensabile non solo per affrontare lo studio del fenomeno delle assenze dal lavoro per malattia – come già fece Elton Mayo un secolo fa –, ma anche per studiare i fenomeni del mobbing e dello straining: di natura fra loro totalmente diversa, ma entrambi manifestazione di una patologia dell’ambiente, del contesto lavorativo, prima ancora che causa di sofferenza della singola persona colpita. Poi, certo, il giuslavorista deve saper mettere il sapere accumulato in questi campi del sapere sociologico e psicologico in comunicazione con il sapere giuridico, per trarne un’argomentazione convincente a sostegno della ricostruzione proposta dell’istituto della sospensione del lavoro per malattia e/o dell’interpretazione della norma che disciplina la materia.
Consiglierei loro, innanzitutto, due libri che per me sono stati fondamentali: uno è il libro di Elton Mayo di cui fra dieci anni si celebrerà il centenario della pubblicazione, I problemi umani e socio-politici della civiltà industriale; l’altro è il libro di Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin e Don D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, sul quale dalla fine degli anni ’60 si è fondata la c.d. “scuola sistemica”, fondata sull’idea che nessun comportamento umano può essere capito e spiegato se non come reazione al comportamento delle altre persone con cui esso interagisce. A ben vedere Elton Mayo lo intuisce e applica questo criterio di lettura, nello studio dei comportamenti nel luogo di lavoro, con trent’anni di anticipo rispetto alla esposizione compiuta della teoria sistemica da parte di Paul Watzlawick. L’approccio sistemico a me sembra assolutamente indispensabile non solo per affrontare lo studio del fenomeno delle assenze dal lavoro per malattia – come già fece Elton Mayo un secolo fa –, ma anche per studiare i fenomeni del mobbing e dello straining: di natura fra loro totalmente diversa, ma entrambi manifestazione di una patologia dell’ambiente, del contesto lavorativo, prima ancora che causa di sofferenza della singola persona colpita. Poi, certo, il giuslavorista deve saper mettere il sapere accumulato in questi campi del sapere sociologico e psicologico in comunicazione con il sapere giuridico, per trarne un’argomentazione convincente a sostegno della ricostruzione proposta dell’istituto della sospensione del lavoro per malattia e/o dell’interpretazione della norma che disciplina la materia.
.

