Un tentativo di presentazione estremamente sintetica delle caratteristiche e delle criticità più rilevanti dell’ordinamento giuslavoristico del nostro Paese, in funzione di una comparazione con quelle dell’ordinamento cinese
.
Testo della comunicazione che svolgerò il 2 dicembre 2025 al seminario promosso dallo Studio Ichino Brugnatelli e Associati suI diritti del lavoro italiano e cinese a confronto, con la partecipazione della prof.ssa Wenwen Ding, dell’Università di Pechino, e slides di cui mi sono avvalso per la presentazione – In argomento v. anche, su questo sito, Il codice del lavoro cinese
.
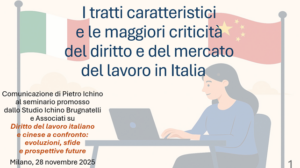 Scarica le slides in formato PDF
Scarica le slides in formato PDF
Chi desideri partecipare all’incontro è pregato di comunicarlo entro il 30 novembre a biancamaria.campasso@ichinobrugnatelli.it
Chi desiderasse ricevere queste slides in formato Power Point, in modo da poterle proiettare con l’attivazione delle “animazioni”, può farmene richiesta indicando l’utilizzazione che intende farne
.
..
I tratti caratteristici e le maggiori criticità
del diritto e del mercato del lavoro in Italia
(segue la versione inglese di questo stesso testo)
Poiché mi si chiede di evidenziare sinteticamente le caratteristiche più rilevanti, sul piano comparatistico, del diritto del lavoro italiano, propongo queste osservazioni.
1. L’ordinamento italiano come parte dell’ordinamento UE
Il nostro Paese è membro dell’Unione Europea e si conforma dunque ai principi e alle regole del più ampio ordinamento sovranazionale continentale. Per quel che riguarda la disciplina del lavoro, l’allineamento comporta, in particolare:
- la libertà di circolazione, di insediamento e di lavoro di tutti i cittadini europei sul e dal nostro territorio nazionale;
- il loro diritto ai servizi pubblici e privati di orientamento professionale, di formazione, di mediazione fra domanda e offerta di lavoro (c.d. collocamento);
- il diritto dei lavoratori dipendenti a una informazione chiara e dettagliata, in forma scritta, circa le condizioni di lavoro, l’entità e la struttura della retribuzione;
- il divieto di discriminazione di genere, razza, nazionalità, etnia, credo politico o religioso, attività sindacale, età, orientamento sessuale;
- il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e a una organizzazione del lavoro che ponga al primo posto il benessere delle persone;
- i limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale e quelli minimi dei riposi giornaliero, settimanale e annuale;
- la protezione della continuità dell’occupazione mediante limiti alla facoltà di licenziamento (su questo punto tornerò tra breve) e al ricorso al contratto a termine…
- … e mediante la disciplina procedurale del licenziamento collettivo, inteso come quello che coinvolge almeno cinque dipendenti di una stessa azienda nell’arco di 120 giorni;
- la disciplina della continuità del rapporto di lavoro nel caso del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda.
Al di fuori del vincolo UE, ma sempre in linea con quanto previsto negli ordinamenti degli altri Stati membri, legge e contrattazione collettiva prevedono e disciplinano una gamma assai ampia di casi di sospensione del lavoro, con o senza retribuzione, in funzione di impedimenti, interessi o esigenze familiari o sanitarie della persona, nonché in funzione dell’assunzione da parte sua di cariche pubbliche, o di funzioni sindacali.
2. Peculiarità dell’ordinamento del lavoro italiano
Rispetto agli ordinamenti nazionali della maggior parte degli altri Paesi membri dell’UE il nostro diritto del lavoro si caratterizza e differenzia, invece, per gli aspetti che qui di seguito espongo in sintesi.
- Il regime di abstention of law in materia di standard retributivo minimo – La materia è riservata in linea di principio alla contrattazione collettiva di settore di livello nazionale. Da due anni, tuttavia, si è assistito a interventi molto incisivi dei Giudici del Lavoro, mirati a correggere le situazioni nelle quali il contratto collettivo – ancorché stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative – stabilisce standard minimi ritenuti troppo bassi. Ultimamente il Parlamento ha delegato il Governo a disciplinare con atto legislativo le situazioni nelle quali la contrattazione collettiva fa difetto o è in ritardo; ma non è dato sapere come questa delega verrà esercitata. L’ordinamento italiano si trova dunque oggi in una fase di crisi e di transizione – e di conseguente incertezza – riguardo alla titolarità dell’“autorità salariale”.
- Gli standard minimi fissati dai contratti collettivi a livello nazionale – Negli ultimi cinquant’anni la contrattazione collettiva di settore nazionale si è attenuta a una linea di fissazione di minimi tabellari uguali per tutto il territorio nazionale, sui quali non incidono né le differenze di costo della vita tra le diverse zone, né le differenze di produttività del lavoro. Ne consegue un difetto strutturale degli incentivi economici agli aumenti della produttività del lavoro e alla migrazione della forza-lavoro verso le aziende più capaci di valorizzare il lavoro stesso. In altre parole, l’orientamento evidenziato della contrattazione collettiva nazionale, combinato con l’insufficiente diffusione della contrattazione collettiva aziendale, contribuisce a determinare un effetto depressivo sui livelli retributivi, che sono sostanzialmente fermi da un quarto di secolo.
- Sostegno del reddito nel caso di sospensione del lavoro nell’interesse dell’impresa – In Italia opera da un tempo assai maggiore rispetto agli altri Paesi della UE un sistema pubblico di sostegno del reddito dei lavoratori nel caso di sospensione del lavoro per esigenze o impedimenti dell’impresa (la “Cassa integrazione guadagni”), che per i casi di crisi o ristrutturazione aziendale può coprire periodi di tempo anche molto estesi.
- Disciplina dei licenziamenti individuali – Su questa materia l’ordinamento italiano, nell’ultimo mezzo secolo, è sempre stato caratterizzato da un contenuto protettivo della continuità del lavoro nettamente maggiore rispetto agli altri Paesi UE: a) sia per l’apparato sanzionatorio, che nelle aziende con più di 15 dipendenti prevedeva, fino al 2012, come regola generale la reintegrazione nel posto di lavoro, b) sia per l’orientamento giurisprudenziale prevalente, assai severo nella valutazione del motivo, disciplinare o economico-organizzativo, addotto dall’impresa a sostegno del licenziamento. Nel 2012-15 è stata varata una riforma legislativa tendente a sostituire, come regola generale, la sanzione indennitaria alla sanzione reintegratoria; ma diversi interventi della Corte costituzionale e un orientamento dei Giudici del Lavoro prevalentemente ostile alla riforma hanno notevolmente limitato gli effetti pratici della riforma. Anche la sanzione indennitaria – il cui limite massimo è fissato a 36 mensilità dell’ultima retribuzione per le imprese sopra i 15 dipendenti, 18 mensilità per quelle al di sotto di detta soglia – costituisce un severance cost mediamente superiore rispetto agli altri ordinamenti nazionali UE.
- Disciplina dei licenziamenti collettivi – Anche su questa materia, che pure è oggetto di una direttiva UE, l’ordinamento italiano si caratterizza per un contenuto protettivo della continuità del rapporto di lavoro più intenso rispetto agli altri ordinamenti nazionali UE: a) per effetto della regola posta dalla legge italiana in materia di criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, le cui indeterminatezza aumenta notevolmente l’alea dell’eventuale giudizio; b) per effetto delle incertezze giurisprudenziali circa la sanzione – reintegratoria o indennitaria – applicabile nel caso in cui il giudice ravvisi una violazione della regola in materia di criteri di scelta.
3. Criticità più rilevanti del sistema italiano di diritto del lavoro e del welfare
- Stagnazione della produttività media del lavoro e delle retribuzioni – Si può dunque rilevare una propensione peculiare del sistema italiano nel senso di privilegiare la continuità del rapporto di lavoro più di quanto accada negli altri ordinamenti europei, col risultato che la soglia della produttività minima al di sotto della quale il rapporto si scioglie si colloca mediamente assai al di sotto rispetto a quanto accade oltralpe. Questo contribuisce a mantenere più bassa la produttività media oraria del lavoro in Italia.
La suddetta propensione peculiare del sistema italiano, combinata con il modo in cui gli standard minimi salariali vengono stabiliti da parte della contrattazione collettiva (di cui si è detto sopra), contribuisce a determinare il fenomeno della stagnazione, oltre che della produttività media del lavoro, anche delle retribuzioni medie del lavoro.
- La prospettiva di un grave squilibrio tra lavoratori attivi e pensionati – La riforma del sistema pensionistico abbinata alla Legge Finanziaria 2012 (c.d. Riforma Fornero) garantisce un buon equilibrio attuariale del sistema stesso sul presupposto che la platea dei lavoratori in attività non si restringa. Senonché l’andamento demografico della popolazione italiana fa registrare una perdita di circa 300.000 cittadini italiani ogni anno, compensata solo in piccola parte dal prevedibile flusso migratorio in entrata; ciò che significa una riduzione del 10% circa della platea delle persone attive nel mercato del lavoro entro i prossimi vent’anni. Basterebbe anche una riduzione assai minore per mettere in crisi l’equilibrio attuariale del nostro sistema pensionistico; ma l’opinione pubblica e la politica nazionale non hanno ancora messo a fuoco sufficientemente questo problema.
- Scarsa partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro – Nonostante qualche miglioramento registratosi nel corso dell’ultimo decennio, il tasso di occupazione femminile e giovanile in Italia è tra i più bassi d’Europa. Questa potrebbe costituire una buona notizia, se il Paese ne traesse motivo per una politica molto incisiva volta ad allineare i tassi di occupazione femminile e giovanile rispetto alla media UE, così compensando il deficit di offerta di manodopera di cui si è testé detto e contribuendo a
– riequilibrare il sistema pensionistico;
– aumentare il reddito complessivamente prodotto e la ricchezza del Paese.
Senonché per ottenere questo occorrerebbe un salto di qualità nelle politiche attive del lavoro: terreno, questo, sul quale l’Italia è ancora molto indietro rispetto al Centro e al Nord-Europa.
.

The Characteristics and Major Critical Issues
of the Italian Labor Law and Labor Market
Lecture by Pietro Ichino at the seminar organized by Ichino Brugnatelli e Associati on A Comparison of Chinese and Italian Labor Law – Milan, November 28, 2025
Since I have been asked to briefly highlight the most significant characteristics of Italian labor law, I will share with you the following observations.
- The Italian legal system as part of the EU legal system
Our country is a member of the European Union and therefore conforms to the principles and rules of the broader supranational continental legal system. With regard to labor law, this alignment entails, in particular:
- the freedom of movement, settlement, and work of all European citizens within and from our national territory;
- their right to public and private services for career guidance, training, and job matching (s.c. placing);
- the right of employees to clear and detailed written information regarding working conditions and the amount and structure of compensation;
- the prohibition of discrimination based on gender, race, nationality, ethnicity, political or religious belief, trade union membership, age, or sexual orientation;
- the right to a safe working environment and to work organization that prioritizes people’s well-being;
- maximum limits on weekly working hours and minimum limits on daily, weekly, and annual rest periods;
- the protection of employment continuity through limits regarding dismissals (I will return get back to this point shortly) and fixed-term contracts…
- …and through procedural rules for collective dismissals, defined as those involving at least five employees of the same company within a 120-day period;
- the regulation of continuity of the employment relationship in the event of the transfer of a business or business unit.
Outside of EU constraints, but still in line with the provisions of other member States, law and collective bargaining agreements provide for and regulate a very broad range of cases of exemption from work obligation, with or without pay, based on impediments, interests, or family or health needs of the employee, as well as based on the assumption of public office or trade union functions.
- The peculiarities of the Italian Labor Law System
Compared to the national laws of most other EU member States, our labor law is characterized by the aspects summarized below.
- The “abstention of law” regime regarding minimum wage standards – Since the end of the second World War, setting wage standards is in principle reserved to national sectoral collective bargaining. Over the past two years, however, we have witnessed very incisive interventions by labor Courts, aimed at correcting situations in which collective agreements — even those stipulated by the most representative trade unions — establish minimum standards deemed too low. Recently, the Parliament has delegated the Government the power to regulate, through a legislative act, situations in which collective bargaining is lacking or delayed; however, how this delegation will be exercised is not known. The Italian legal system is therefore currently in a phase of crisis and transition—and consequent uncertainty—regarding the ownership of the “wage authority.”
- Minimum standards set by national collective agreements – Over the past fifty years, national sectoral collective bargaining has adhered to a policy of setting uniform minimum wages across the country, irrespective of regional cost-of-living differences or labor productivity differences. This results in a structural flaw in economic incentives for increased labor productivity and for workforce migration to companies that are more capable of valorizing labor. In other words, the prevailing trend of national collective bargaining, combined with the insufficient diffusion of company-level collective bargaining, contributes to a depressive effect on wage levels, which have been essentially stagnant over the last quarter of a century.
- Income support in the event of a temporary lay-off – In Italy, a public system of income support for workers in the event of work suspension due to company needs or impediments (the Cassa Integrazione Guadagni) has been in operation since the Fifties: much earlier than in any other EU country. In cases of corporate crisis or restructuring, this system can cover even very long periods of time.
- Regulation of individual dismissals – In this area, over the last half century the Italian legal system has always been characterized by a greater level of protection for employment continuity compared to other EU countries: a) until 2012, in case of dismissal deemed unfair by the Court the sanctions system provided for reinstatement as a general rule for companies with more than 15 employees; b) the prevailing case law is very strict in assessing the disciplinary or economic-organizational reasons put forward by the company for issuing a dismissal. A legislative reform was enacted in 2012-15, aiming at replacing reinstatement with compensatory damages as the general rule; however, several interventions by the Constitutional Court and a predominantly hostile stance among labor Courts against the reform have significantly limited its practical effects. The compensatory penalty — the maximum limit of which is set to-day at 36 months’ salary for companies with more than 15 employees, and 18 months’ salary for those below this threshold — also contributes to a higher average severance cost compared with any other EU national system.
- Collective dismissals – Even in this area, which is regulated by an EU directive, the Italian legal system is characterized by a more intense protection of the continuity of the employment relationship than other EU national legal systems: a) due to the rule established by Italian law regarding the criteria for selecting employees to be dismissed, the vagueness of which significantly increases the risk of any potential judgment; b) due to the uncertainties in case law regarding the sanction – reinstatement or compensation – applicable in the event the selection criteria applied by the company for issuing the dismissal are deemed violated.
3. Major Critical Issues in the Italian Labor and Welfare Law System
- Stagnation of Average Labor Productivity and Wages – I have stressed (see §§ 2.d and e) the peculiar strong tendency within the Italian system to prioritize the continuity of employment relationships. As a result, the minimum productivity threshold below which employment relationships are terminated is, on average, much lower than in other European countries. This contributes to maintaining an average hourly labor productivity which in Italy is lower than in other EU countries.
The aforementioned peculiar tendency within the Italian system, combined with the way minimum wage standards are established by collective bargaining (discussed above, §§ 2.a-b), contributes to the phenomenon of stagnation not only in average labor productivity but also, consequently, in average wages.
- The prospect of a serious imbalance between active workers and retirees – The pension system reform linked with the 2012 Budget Law (the so-called Fornero Reform) ensures a good actuarial balance of the system, assuming that the number of active workers does not shrink. However, the demographic trend of the Italian population is resulting in a loss of approximately 300,000 Italian citizens per year, only partially offset by the expected influx of incoming migrants. This results in a reduction of approximately 10% in the number of people in the labor market over the next twenty years. Even a much smaller reduction would be enough to undermine the actuarial balance of our pension system; but public opinion and national policymakers are not yet addressing this issue sufficiently.
- Low labor market participation of women and young people – Despite some improvements over the past decade, Italy’s female and youth employment rate is among the lowest in Europe. Paradoxically, this could be good news if the country were to implement a very effective policy aimed at aligning female and youth employment rates with the EU average, thus compensating for the aforementioned labor supply deficit and contributing to:
– rebalancing the pension system;
– increasing the country’s overall income and wealth.
However, achieving this goal would require a qualitative leap in active labor market policies: an area in which Italy still lags far behind Central and Northern Europe.
.
