Le trasformazioni maggiori sono costituite dalla perdita di peso dell’orario nella struttura della prestazione e il rovesciamento del paradigma del mercato, dove è sempre più frequente il caso della persona in grado anch’essa di scegliere l’impresa, rispetto al caso in cui a scegliere è solo l’impresa
.
Intervista a Pietro Ichino a cura di Gaetano Gemiti, per l’inserto Giustizia del quotidiano La Verità – In argomento v. anche la mia relazione al convegno di Rovereto del 6 marzo 2025 su Il cambio di paradigma del mercato dell’occupazione e le nuove tecniche di protezione del lavoro
.
 Sia per la misurazione della produttività, sia per l’inserimento del lavoro nell’organizzazione aziendale, che è ottenuto sempre più diffusamente per mezzo di strumenti informatici e telematici, «oggi il tempo ha perso valore nel mondo del lavoro». È questo il mutamento di maggior rilievo che Pietro Ichino coglie mettendo a confronto lo scenario odierno con quello del secolo passato, dove «il lavoro dipendente si caratterizzava innanzitutto per e sere misurato sulla base della sua estensione temporale». Oltre che, aggiunge il professore giuslavorista, «per essere integrato nell’organizzazione aziendale attraverso il vincolo del coordinamento temporale, cioè del lavorare tutti nello stesso orario». L’estensione e il coordinamento dell’orario settimanale sono vincoli «del secolo scorso» in un mercato dove peraltro, osserva ancora Pietro Ichino, sale la percentuale di lavoratori che possono permettersi di scegliere l’impresa, rispetto ai casi in cui è l’impresa la sola a esercitare una libertà di scelta.
Sia per la misurazione della produttività, sia per l’inserimento del lavoro nell’organizzazione aziendale, che è ottenuto sempre più diffusamente per mezzo di strumenti informatici e telematici, «oggi il tempo ha perso valore nel mondo del lavoro». È questo il mutamento di maggior rilievo che Pietro Ichino coglie mettendo a confronto lo scenario odierno con quello del secolo passato, dove «il lavoro dipendente si caratterizzava innanzitutto per e sere misurato sulla base della sua estensione temporale». Oltre che, aggiunge il professore giuslavorista, «per essere integrato nell’organizzazione aziendale attraverso il vincolo del coordinamento temporale, cioè del lavorare tutti nello stesso orario». L’estensione e il coordinamento dell’orario settimanale sono vincoli «del secolo scorso» in un mercato dove peraltro, osserva ancora Pietro Ichino, sale la percentuale di lavoratori che possono permettersi di scegliere l’impresa, rispetto ai casi in cui è l’impresa la sola a esercitare una libertà di scelta.
Ne consegue che…
«… se il discorso riguarda il modo in cui si lavora, la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo è sempre meno netta, proprio per via di questa progressiva irrilevanza dell’elemento tempo. Qui mi riferisco, ovviamente, soprattutto al lavoro che ha per oggetto flussi di informazioni, non al lavoro manuale».
Può spiegare meglio?
Il lavoro dipendente del secolo scorso si caratterizzava innanzitutto per essere misurato sulla base della sua estensione temporale; inoltre per esere integrato nell’organizzazione aziendale per mezzo del vincolo del coordinamento temporale, cioè del vincolo del lavorare tutti nello stesso orario. Oggi il tempo è sempre meno rilevante sia per la misurazione della quantità di lavoro, sia per il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, che è ottenuto sempre di più diffusamente per mezzo di strumenti informatici e telematici. Ne consegue che la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo è sempre meno netta. Mi riferisco, ovviamente, soprattutto al lavoro che ha per oggetto flussi di informazioni, non al lavoro manuale.
Se invece ci riferiamo al mercato del lavoro, che cosa è cambiato tra questo secolo e il precedente?
È cambiato il paradigma fondamentale del mercato del lavoro, che non è più soltanto il luogo nel quale l’imprenditore seleziona e ingaggia i propri collaboratori, ma è sempre di più anche il luogo dove sono le persone che vivono del proprio lavoro a scegliere l’impresa, avendo una possibilità di scelta più o meno ampia tra diverse alternative. La domanda di lavoro espressa dalle imprese oggi in Italia resta per larga parte insoddisfatta per carenza dell’offerta: quando le imprese cercano persone da assumere, in un caso su due attendono mesi prima di riuscire a coprire la posizione. Il lavoratore che può scegliere è un lavoratore contrattualmente più forte; il problema è che c’è ancora una fascia di lavoratori che non sono in grado di scegliere.
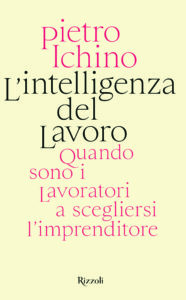 Come incide questo rovesciamento del paradigma sulla sua idea della flexicurity?
Come incide questo rovesciamento del paradigma sulla sua idea della flexicurity?
È sempre più indispensabile una rete capillare di servizi efficaci al mercato del lavoro: orientamento scolastico e professionale; formazione mirata agli sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e la cui efficacia sia monitorata in modo sistematico; informazione analitica su domanda e offerta esistenti; assistenza intensiva a chi ha maggiori difficoltà a districarsi nel mercato del lavoro; assistenza anche alla mobilità geografica delle persone e delle famiglie, perché chi è più mobile ha maggiore libertà effettiva di scelta e dunque maggiore forza contrattuale. È ancora una questione di politiche attive del lavoro. Sulle quali l’Italia è molto indietro rispetto al centro- e al nord-Europa.
Il modello della settimana corta desta sempre più interesse. In alcuni Paesi, di cui diversi europei, l’hanno già sperimentata. In Italia, come e dove potrebbe funzionare?
La settimana lavorativa di quattro giorni è già sperimentata anche in Italia. È un modello di organizzazione del lavoro che può soddisfare esigenze diverse, sia dal lato delle imprese sia da quello dei lavoratori. Ma forse, proprio per la perdita di peso che il tempo ha nell’organizzazione del lavoro, di cui abbiamo parlato prima, quello della distribuzione dell’orario settimanale è un tema destinato a perdere anch’esso un po’ del rilievo che ha avuto in passato. In ogni caso, è importante che su questa materia sia la contrattazione, soprattutto quella aziendale e quella individuale, a svolgere il ruolo decisivo.
Che impatto avrà l’avvento dell’IA sul mercato del lavoro e sul modo di lavorare?
Come tutte le rivoluzioni tecnologiche precedenti, anche questa farà sparire molti mestieri oggi svolti dalle persone ma ne potenzierà molti e ne farà nascere molti altri. Il problema è che li potenzierà o li farà nascere solo là dove il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale sapranno adeguarsi al nuovo contesto. È anche qui questione di politiche attive del lavoro efficaci.
L’altra settimana il Senato ha approvato definitivamente la legge-delega sulla disciplina degli standard retributivi. Qual è il suo giudizio su questo provvedimento?
In tema di minimum wage la legge prevede che “per i settori non coperti da contrattazione collettiva”, o per quelli il cui contratto collettivo sia scaduto senza essere rinnovato, il ministero del Lavoro stabilisca in via provvisoria il trattamento economico complessivo minimo dovuto ai lavoratori. È un passo avanti non da poco. La parte della legge-delega sulla selezione del contratto collettivo applicabile è invece quella che mi lascia più perplesso.
Quale può essere l’effetto pratico della nuova norma sul salario minimo?
La nuova disposizione consente ora, a ben vedere, l’introduzione di un minimum wage di settore stabilito in via sussidiaria dal governo non solo in tutti i casi – assai frequenti – di pesante ritardo nel rinnovo di un contratto collettivo, ma, se si intende il termine “copertura” come sinonimo di “protezione adeguata”, anche nei casi in cui il governo ritenga che il minimo stabilito dal contratto collettivo applicato non soddisfi il principio sancito dall’articolo 36 della Costituzione. Può essere questo un modo per evitare che il solo rimedio alle disfunzioni del sistema delle relazioni industriali sia il regime di ”supplenza giudiziaria”.
.
