Il filo rosso che lega molte esperienze apparentemente tra loro contraddittorie e il lungo itinerario di elaborazione di una cultura del lavoro controcorrente
.
Intervista a cura di Luca Telese, pubblicata sul quotidiano la Verità il 2 giugno 2020 – Le altre interviste e recensioni relative a La casa nella pineta e L’intelligenza del lavoro sono facilmente raggiungibili attraverso le pagine web rispettivamente dedicate ai due libri
.
.
Le pare normale spendere decine di miliardi per i sussidi passivi, e non stanziare un euro per le politiche attive?
E i Navigator?
Impreparati, senza alcuna organizzazione… non per colpa loro, ma quella non è una politica attiva del lavoro seria! Di fatto, sono soldi buttati.
Dice?
Da quattro mesi sono a casa a far nulla, a stipendio pieno e per di più con la ciliegina sulla torta.
Cioè?
L’hanno notato in pochi. Gli hanno dato anche i 600 euro! Risultati zero, ma stipendio pieno e in più il bonus previsto per i disoccupati.
Non crede alle parole del presidente dell’Anpal Mimmo Parisi?
Come si fa a credere a uno che se ne sta più in Mississippi che in Italia e che per il funzionamento dell’Agenzia per più di un anno non ha fatto niente?
 Pietro Ichino, uno dei giuslavoristi italiani più noti, una vita sotto scorta, ha appena pubblicato un saggio polemico L’intelligenza del lavoro (Rizzoli, 18 euro) che è la sua critica al sistema italiano di protezione del lavoro. Parte da una tesi che può sembrare provocatoria: “Sono i lavoratori che devono imparare a scegliersi il datore di lavoro”. Ed essere posti in condizione di farlo.
Pietro Ichino, uno dei giuslavoristi italiani più noti, una vita sotto scorta, ha appena pubblicato un saggio polemico L’intelligenza del lavoro (Rizzoli, 18 euro) che è la sua critica al sistema italiano di protezione del lavoro. Parte da una tesi che può sembrare provocatoria: “Sono i lavoratori che devono imparare a scegliersi il datore di lavoro”. Ed essere posti in condizione di farlo.
Da che famiglia viene, professore?
(Sospiro, sorriso) Discorso lungo… riassumiamo: mio padre, mia madre e i nonni materni erano avvocati.
Alcuni tra i più prestigiosi di Milano.
Avevano uno studio molto noto, lo stesso dove era stata fondata la Banca Commerciale nel 1894.
Una tradizione gloriosa.
Mio nonno Carlo ci era entrato praticante nel 1919, poi ne divenne contitolare.
Sua madre Francesca, donna, laureata e avvocato nel primo dopoguerra: una mosca bianca.
Mio padre, cresciuto negli ideali del fascismo, partì per la guerra, tornó “defascistizzato” e deluso dopo due anni di prigionia, e dopo la fuga vergognosa del Re.
Erano molto diversi.
Uh! Da fidanzati, lui le scrisse una lettera in cui sosteneva la superiorità dell’uomo sulla donna, le chiedeva di riconoscere questo principio.
Non ci credo.
(Sorriso) Nemmeno lei, a dire il vero. Mia madre accettó, ma poi diventó la vera capo-famiglia, quella che prendeva tutte le decisioni importanti. Eh eh…
Che idee politiche aveva papà Ichino?
Votava sinistra democristiana alla Camera, dove si poteva scegliere con la preferenza, e partito socialista al Senato.
Voto disgiunto ante-litteram.
Sì. I miei erano molto insoddisfatti dell’Italia degli anni ’50, sempre a caccia di… profeti.
Ne troveranno almeno uno: Don Milani.
In una prima vita, lui era stato fidanzato della cugina prima di mia madre. I miei divennero grandi sostenitori della scuola di Barbiana.
L’ho raccontato ne La casa nella pineta. Nel 1959 venne a casa nostra con i primi sei allievi. Ricordo i materassi in terra per ospitare tutti: grande emozione.
Fu una impronta decisiva?
Sì. Don Milani quando avevo solo 13 anni mi disse, indicando con un gesto circolare la mia casa: “Per tutto questo non sei ancora in colpa. Ma da quando sei maggiorenne se non restituisci tutto diventa peccato”.
Caspita. “Restituire”, ovvero fare mestieri socialmente utili?
Sì: che per lui erano soprattutto il sindacalista o l’insegnante.
 Lei nella sua vita ha fatto entrambi.
Lei nella sua vita ha fatto entrambi.
Vero. A tratti anche tutti e due insieme.
Come?
Da sindacalista misi in piedi alla Camera del Lavoro un corso per i delegati dei consigli, che ebbe molto successo. Avevo una formazione profondamente religiosa. A 12 anni parrocchia, e Azione Cattolica. Sentivo il dovere di mettere in comune il privilegio della cultura.
Parrocchia e Azione Cattolica, però poi nella Cgil. Perché?
Perché erano gli anni della fine del collateralismo tra la Chiesa e partito, o sindacato. E poi la Cgil milanese era quanto di più culturalmente aperto si potesse immaginare.
Il suo primo voto?
Nel 1966 Psi e poi PSIUP. Quindi arriva l’onda del 1968 e cambia tutto.
 Lei entra nel sindacato e nel PCI.
Lei entra nel sindacato e nel PCI.
Dal 1969 al 1979 lavoro nella Cgil. Che poi mi manda in Parlamento.
Una carriera bruciando le tappe.
Avevo solo 29 anni. L’impressione maggiore fu far parte del gruppo parlamentare comunista.
Perché?
Arrivavo da una Cgil lombarda aperta e riformista. Avevo idee poco ortodosse, che nel Pci non avevano vita facile.
Ad esempio?
Già allora contestavo il monopolio statale del collocamento. Volevo il riconoscimento del part-time.
Non esisteva già?
Era pressoché sconosciuto. Si pagava la stessa contribuzione del tempo pieno!
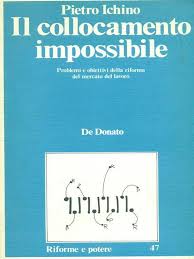 Era un altro mondo. Rompeva gli schemi e forse non solo quelli.
Era un altro mondo. Rompeva gli schemi e forse non solo quelli.
Pubblicai Il collocamento impossibile, denunciando un ferrovecchio che era difeso con forza da Pci, Psi e anche Dc.
Anche la Dc?
Soprattutto! I collocatori erano quasi tutti democristiani, della corrente di Donat Cattin.
Il ministro della corrente Forze nuove.
Il capo del loro sindacato, un certo Caponnetto, li aveva portati in dote a Forze nuove in cambio di un posto di rilievo al ministero del Lavoro
Nessuna parentela con il giudice?
Zero. Erano quelli che consentivano di aggirare la graduatoria per le assunzioni. Dicevano al lavoratore: “iscriviti alla lista come battilastra” oppure “come dattilografa con conoscenza del russo e fai chiedere questa qualifica dall’azienda”. In molti luoghi c’era una tariffa per questo “servizio”: metà della prima busta paga.
Incredibile. E quanto duró?
Raccontai questi casi. Denunciai per peculato un dipendente pubblico disonesto mandandolo in galera.
Era uno strappo con il sindacato?
No. Era ovvio che queste cose le scoprivo proprio perché lavoravo nel sindacato. E la Cgil milanese mi appoggiava in questa battaglia.
Ma il Pci no. La ricandidò?
(Risata) Si, ma a Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia, dove le mie idee erano molto sgradite ai compagni. Così non venni rieletto e mi trovai senza lavoro.
Un disastro.
Sì e no. Dedicai due anni a scrivere un libro – Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro – e grazie a quello vinsi la cattedra di diritto del Lavoro. Era il 1986.
Diventó professore.
Cinque anni a Cagliari. Nel 1991 mi chiamarono alla Statale di Milano, Scienze politiche.
Ruppe con la Cgil?
No. Certo, per i corsi di formazione mi invitava molto di più la Cisl. Ma il filo con la Cgil non si è mai spezzato.
La sua vita cambia quando viene ucciso Marco Biagi il 19 marzo 2002.
Da allora sono sotto scorta. Ma erano stati peggio i tre anni precedenti, dopo l’assassinio di Massimo D’Antona.
Sotto scorta ancora oggi?
Ho chiesto quattro volte che me la togliessero. La prima volta nel 2006.
Non l’hanno fatto?
Un giorno del novembre 2006 il prefetto Lombardi mi parló in privato: “Ichino. Non possiamo: stanno organizzando un attentato contro di lei”.
Ed era vero.
Mi mostró delle foto: riconobbi due studenti. Amarilli Caprio e Davide Bortolato, venuti da Padova proprio per questo attentato.
Li conosceva?
Bortolato di sfuggita, l’avevo sentito parlare in qualche assemblea.
E Amarilli Caprio?
Rimasi di stucco. In Università l’avevo notata, eccome. Anche perché era una bellissima ragazza.
Lei al processo si costituì parte civile.
Dissi: “Sono pronto a ritirarmi, se mi si riconosce il diritto di non essere aggredito”.
Quanti lo fecero?
(Sorriso amaro) Nessuno. Anzi contro di me in Aula gli imputati inveirono in modo rabbioso.
Hanno avuto nove anni.
Però li hanno scontati tutti. Poi sono usciti con tutti gli onori.
In che senso?
Bortolato venne accolto a Padova, nel suo bel centro sociale con uno striscione: “Onore ai compagni arrestati, giustizia per i servi del capitale”.
In quei giorni la campagna contro Ichino diventa virale.
La Digos mi informa che sono indicato come “traditore” e “servo dei padroni”.
Le vittime delle nuove Br erano per lo più “riformisti”, non “padroni”.
Le Br colpivano chi si proponeva di risolvere i problemi e di costruire ponti: Giugni, Tarantelli, Biagi, D’Antona.
Lei torna in Parlamento nel 2008, scelto da Veltroni. L’anno prima era stato tra i fondatori del Pd. Poi però passa a Scelta Civica.
Nel 2011 Monti aveva incluso nella prima lista del suo governo come ministro del lavoro.
E cosa accadde?
Orfini disse qualcosa del tipo: “Se Ichino è il ministro del lavoro, questo governo muore prima di nascere”.
Lei che ha fatto?
Nulla. Ho finito la legislatura col PD, ma nel 2013 mi sono candidato con Monti. Nel 2015 sono rientrato nel Pd con tutto il gruppo dei senatori di SC.
Nel 2018 però non si è ricandidato.
Avevo fatto tre legislature.
Ora si è ritirato dal lavoro?
Mica tanto. Dall’anno scorso ho la pensione, ma continuo a insegnare, a seguire le tesi di laurea, e soprattutto a scrivere.
Senza retribuzione.
Sì, a questo punto solo per passione. Ho più di quel che mi serve per vivere.
La commovente lettera per sua moglie, morta per una paralisi progressiva, ha fatto il giro del mondo.
L’ho scritta l’ultima notte in cui l’ho assistita, per le mie figlie e i nipoti.
L’ha messa sul suo sito.
Sì, perché lo leggono i miei nipoti, sparsi in tutto il mondo: Città del Capo, Los Angeles, Londra, Brasile, Inghilterra. Poi di quel post si è impadronito il circo mediatico ed è divenuto virale anche quello: 250mila visualizzazioni.
Sorpreso?
Un po’. Moltissimi mi hanno ringraziato per quello scritto. Mai sentito intorno a me tanto affetto.
Il suo bersaglio polemico: “la fine del lavoro”
Mi spiace per Rifkin ma quella è proprio una fake news: nel 1977 c’erano 17 milioni di italiani al lavoro, dopo 40 anni di sviluppo tecnologico accelerato erano 23!
Ma non sono fissi.
Se è per quello non sono fisse più neppure le imprese: nascono e muoiono con un ritmo molto più rapido che in passato. La verità? Non manca tanto il lavoro, quanto l’intelligence necessaria per trovarlo.
Lei dice che occorre l’intelligenza, la capacità di capire il mercato per poterlo usare a proprio vantaggio.
Non è utopia. Già oggi molti scelgono l’imprenditore.
Possibile?
Quando delimitano la zona, o il settore professionale, o le dimensioni dell’azienda, o migrano per trovare di meglio. Che debbano poterlo fare tutti, è la Costituzione, articolo 4, a dirlo.
E invece?
Se molti non possono farlo è in parte perché mancano i servizi di informazione e formazione mirata, in parte perché il nostro Paese respinge gli imprenditori stranieri.
Esempio?
Uno, clamoroso. Il No dei sindacati alle ferrovie ticinesi – la società Ticino-Lombardia – che nel 2005 proponevano ai ferrovieri lombardi doppio stipendio in cambio della rinuncia al doppio macchinista in cabina.
La rivoluzione digitale distrugge occupazione?
Ne distrugge e ne crea. Oggi senza innovazione non sopravvive né l’impresa né il lavoro.
Ma l’innovazione crea esuberi.
 E nuove occasioni di lavoro. Ricordo le 900mila lavandaie italiane che lavoravano con le mani nell’acqua fredda.
E nuove occasioni di lavoro. Ricordo le 900mila lavandaie italiane che lavoravano con le mani nell’acqua fredda.
Fino a quando è arrivata la lavatrice, negli anni sessanta.
Appunto. Non sono diventate barbone, ma operaie e dattilografe. Il tasso di occupazione femminile non è diminuito, è cresciuto.
E il sindacato?
Dovrebbe essere l’intelligenza collettiva che guida i lavoratori nella scommessa comune con il buon imprenditore sull’innovazione.
Qualche volta sì, qualche volta no. Prenda l’Alitalia nel 2008, o la Fiat, e la guerra a Marchionne. Se avesse vinto il No avremmo avuto un manager di Stato. Meglio?
Lei cita come modello la Nissan di Sunderland, nel nord-Inghilterra.
A metà degli anni ’80 il Sindacato dell’automobile britannico AUEW capì che il piano industriale dei giapponesi era buono.
Anche se rompeva tutti i vecchi schemi.
Oh sì. Nel 1983 proponevano l’“impresa piatta”: tutti devono fare tutto, solo il 75% del monte-salari è fisso.
E poi premi di gruppo e individuali.
Sì. E scommessa vinta: nel 2000 arrivano a prendere il doppio dei metalmeccanici italiani e il 50% in più che in Uk.
A che servono i sindacati?
A distinguere i piani industriali buoni dalla fuffa.
In molti casi non hanno saputo farlo. Per esempio nel caso di Alitalia. No ad Air France, sí alla cordata di “capitani coraggiosi” dei quali nessuno aveva mai fatto volare un aereo!
E poi?
Bisogna aprire agli stranieri. Per decenni ha prevalso una chiusura bi-partisan.
Perché?
Da destra in nome dell’italianità delle imprese. Da sinistra per un rifiuto pregiudiziale verso le multinazionali. Nel 1986 abbiamo detto no a Ford in Alfa Romeo, poi nel 2000 ad AT&T in Telecom, ad Abn Ambro in Antonveneta, ad Abertis in Autostrade, abbiamo tentato di dire no anche a Lactalis in Parmalat, questa volta senza riuscirci.
E oggi?
L’entusiasmo per le nazionalizzazioni accomuna Fratelli d’Italia a Leu e a una parte del PD. Penso all’Ilva, ad Alitalia, alla povera Cassa Depositi e Prestiti che deve prepararsi a fare quello che faceva la GEPI negli anni ’70 e ’80.
Lei la chiama “reazione pavloviana”.
È quello che accade in Italia ogni volta che un’impresa chiude. Come nel caso Whirpool: si preferisce sempre, a priori, tenerla in vita con la respirazione bocca a bocca, piuttosto che garantire ai lavoratori sicurezza nella transizione al lavoro buono che si offre altrove.
E invece?
Prevale l’idea della tutela nel posto di lavoro; ma quello che serve di più è il sostegno e la protezione nel mercato.
Tradotto in parole povere?
Anziché cercare il lavoro buono che c’è, investendo in servizi efficaci e moderni di orientamento e formazione, si resta attaccati con le unghie e coi denti a quello cattivo, che è perso.
E qui si torna ai Navigator.
Nel nord-Europa i Job advisor hanno due o tre anni di formazione post laurea. Questi nostri sono ragazzi che del mercato del lavoro e dei servizi di orientamento sanno pochissimo.
È difficile costruire un nuovo modello.
Dice? I paesi arretrati hanno una sola fortuna: quella di poter copiare ciò che di buono fanno i paesi più avanzati.
E invece?
Invece che investire sulla formazione mirata alla buona domanda di lavoro che c’è, preferiamo spendere dieci volte di più in assistenza.
.











