L’ultima sentenza della Consulta sui requisiti per l’accesso dei sindacati alle prerogative previste nel Titolo III dello Statuto dei lavoratori segna una inversione a U rispetto alla sua giurisprudenza sulla materia dell’ultimo trentennio; ma la motivazione non la esplicita e non spiega perché ciò che è stato ritenuto ragionevole trent’anni fa non lo sia più oggi
.
Saggio in corso di pubblicazione sulla Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 4/2025, parte I – In argomento v. anche, su questo sito, il mio articolo pubblicato su lavoce.info il 24 settembre 2019, Rappresentanza sindacale: il nodo difficile da sciogliere
.
Sommario
1. La supplenza della Corte rispetto all’inerzia del legislatore e i motivi di perplessità riguardo al modo in cui essa è svolta.
2. I precedenti: le sentenze costituzionali n. 1/1994 e n. 244/1996 e quella più recente, n. 231/2013.
3. Il revirement contenuto nella sentenza n. 156/2025 rispetto alle sentenze n. 1/1994 e n. 244/1996.
4. Il nuovo varco aperto dalla Corte per l’accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto, e gli interrogativi in proposito.
5. Segue – La “madre di tutte le questioni”, in materia di rappresentatività sindacale: quali sono i confini della “categoria”?
6. Auspicabilità, ma non vincolo costituzionale, di una riforma della materia ad opera del legislatore ordinario.
7. Una riforma possibile.
-

Una seduta della Corte costituzionale italiana
La supplenza della Corte rispetto all’inerzia del legislatore e i motivi di perplessità riguardo al modo in cui essa è svolta
Mai come in questa stagione del diritto sindacale e del lavoro – e ancor più a seguito della sentenza 30 ottobre 2025 n. 156, qui in esame, in tema di rappresentanza nei luoghi di lavoro – si è manifestato il ruolo di supplenza che la Corte costituzionale è costretta a svolgere in conseguenza dell’“inerzia sistemica” del legislatore ordinario: inerzia che trova una sorta di fondamento strutturale nell’inattuazione dell’art. 39 della Carta (v. in proposito ultimamente B. Caruso, La rappresentatività sindacale dopo la sentenza n. 156/2025 ecc., WP CSDLE D’Antona n. 504/2025). La sentenza trae origine da un caso nel quale sono evidenziate le conseguenze estreme della disciplina della materia in vigore da trent’anni, che la Corte ha inteso correggere; ma il modo in cui la supplenza legislativa è stata svolta fa sorgere qualche perplessità per un aspetto non secondario e alcuni interrogativi sugli effetti pratici della sentenza.
La perplessità, di natura teorica, riguarda il contrasto logico insanabile tra il contenuto di quest’ultima decisione e quello della sentenza che trent’anni or sono ammise il referendum sull’art. 19 St. lav., poi celebratosi nel giugno 1995, nonché quello di un’altra sentenza di due anni successiva: a questo tema sono dedicati i §§ 2 e 3 che seguono. Nessuno, certo, può scandalizzarsi per un’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che la porti a mutamenti di orientamento anche rilevanti su singoli punti; ma dal Giudice delle leggi che contraddice una propria decisione precedente ci si attende una esplicitazione del revirement e una sua motivazione trasparente. Nella sentenza n. 156 del 2025, invece, il contrasto con l’orientamento precedente non è esplicitato e conseguentemente non ne sono neppure spiegati adeguatamente i motivi.
Gli interrogativi – di natura pratica – riguardano invece alcuni problemi di non facile soluzione che sorgono per l’applicazione concreta della nuova regola posta dalla Corte in via provvisoria, nell’attesa dell’auspicata riforma della materia ad opera del legislatore ordinario: a questi sono dedicati i §§ 4 e 5.
Nei due ultimi paragrafi espongo la mia valutazione circa il contenuto di quella che possiamo chiamare la “riforma provvisoria”, contenuta in questa sentenza, e alcuni appunti circa la riforma legislativa che ritengo auspicabile.
- I precedenti: le sentenze costituzionali n. 1/1994 e n. 244/1996 e quella più recente, n. 231/2013
Il testo dell’art. 19 St. lav., contenente il criterio selettivo per l’accesso ai diritti di cui al Titolo III della stessa legge, è il risultato della modifica della norma prodotta dal referendum del giugno 1995, che abrogò la lettera a ivi originariamente contenuta: per effetto di quel referendum non era più sufficiente che l’associazione sindacale fosse “aderente alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, dovendo qualsiasi associazione soddisfare il criterio previsto nella lettera b dello stesso art. 19, unico rimasto in vita a seguito della consultazione popolare. Da quel momento in poi, dunque, anche l’associazione in ipotesi aderente alle confederazioni maggiori ha dovuto soddisfare il requisito di essere “firmataria di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”.
 Se quel referendum poté avere corso, fu perché la Corte, con la sentenza 12 gennaio 1994 n. 1, preventivamente lo aveva ritenuto ammissibile. Con quella sentenza essa aveva infatti dichiarato compatibile con l’ordinamento costituzionale, in particolare col principio della libertà sindacale di cui all’art. 39, non soltanto
Se quel referendum poté avere corso, fu perché la Corte, con la sentenza 12 gennaio 1994 n. 1, preventivamente lo aveva ritenuto ammissibile. Con quella sentenza essa aveva infatti dichiarato compatibile con l’ordinamento costituzionale, in particolare col principio della libertà sindacale di cui all’art. 39, non soltanto
l’intendimento (massimale) dei promotori di ottenere l’abrogazione di tutti i criteri di “maggiore rappresentatività” adottati dal citato art. 19, primo comma, lett. a) e b), per la selezione delle rappresentanze sindacali aziendali destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III della legge n. 300 del 1970
sotteso a uno dei due quesiti referendari – quello destinato a essere poi bocciato dal voto popolare –, bensì anche
l’intendimento (minimale) di ottenere almeno l’abrogazione dell’indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera a) e l’abbassamento al livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera b)
sotteso all’altro quesito referendario, cioè a quello destinato invece a essere approvato dagli elettori. L’effetto pratico della chiusura della prima porta (lettera a dell’art. 19 originario) veniva dunque considerato pienamente compatibile con la Costituzione.
Nella motivazione di quella sentenza si leggeva inoltre che
Gli esiti dell’eventuale approvazione dei referendum sono coerenti con le finalità perseguite.
La Corte poteva affermare questo perché il quesito referendario “minimale” non si limitava a “chiudere la prima porta” prevista nella lettera a, ma cancellava anche, nella lettera b, gli aggettivi “nazionali o provinciali” riferiti ai contratti collettivi la cui sottoscrizione può dare accesso alle prerogative del Titolo III: così allargando la “seconda porta”, in modo da consentire il passaggio attraverso di essa anche dei sindacati firmatari soltanto di un contratto aziendale.

Luigi Mengoni
Sta di fatto che la sentenza del 1994 ha statuito la compatibilità con l’art. 39 Cost. di una disciplina – quale quella di fatto conseguente al quesito referendario poi approvato dal voto popolare – che ponga come requisito unico necessario e sufficiente per l’accesso ai diritti di cui al Titolo III dello Statuto l’aver firmato un contratto collettivo applicato nell’azienda. Questa statuizione è stata poi confermata e assai più compiutamente argomentata due anni dopo con la sentenza della stessa Corte 12 luglio 1996 n. 244, estensore Luigi Mengoni (in q. Riv., 1996, II, p. 447, con nota di G. Pera); nella quale si legge – § 3.1 – che
l’avere tenuto fermo, come unico indice giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio della lettera b), esteso però all’intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale.
Nella sentenza del 1996, dunque, l’estensore Mengoni sottolinea un profilo assai rilevante di “razionalità pratica” del nuovo ordinamento risultante dall’abrogazione referendaria: il suo perfetto allineamento con l’ordinamento intersindacale; ovvero, se si preferisce dirla così, la rinuncia da parte dell’ordinamento statuale a dare sostegno a organizzazioni sindacali che non siano in grado di conquistarsi da sole il riconoscimento della controparte, così correggendo in qualche misura l’assetto spontaneamente determinato dal libero gioco delle relazioni industriali. Il ragionamento della Corte esposto nella motivazione stesa dal giudice Mengoni può essere espresso anche in questo modo: in seno all’azienda, la libertà sindacale sancita dal primo comma dell’art. 39 Cost. è garantita a tutti i lavoratori e tutte le organizzazioni dal Titolo II dello Statuto e in particolare dagli artt. 14 e 15; rientra invece nella band of reasonableness che delimita la discrezionalità del legislatore ordinario la scelta di riservare il sostegno previsto nel Titolo III alle sole organizzazioni che riescono a conquistare sul campo il riconoscimento della controparte imprenditoriale, con la sottoscrizione di un contratto applicato nell’azienda stessa. È questa – a ben vedere – una scelta assai restrittiva, che ci si sarebbe potuti aspettare da una maggioranza parlamentare di destra invece che da un referendum promosso da un partito di sinistra estrema e dall’ala sinistra del movimento sindacale; ma poiché non si verte in materia di libertà sindacale, bensì di ampliamento o restrizione del novero dei sindacati beneficiari del sostegno statuale di cui al Titolo III, l’ordinamento costituzionale lascia al legislatore ordinario la possibilità di optare per una soluzione più o meno restrittiva entro il solo limite della ragionevolezza.
Il requisito posto dall’art. 19, come modificato dal referendum del 1995, verrà poi reso meno stringente con la sentenza 23 luglio 2013 n. 231 (in q. Riv., 2013, II, p. 979 ss., qui commentata da R. Romei, L’art. 19 St. lav. è incostituzionale, ma nessuno lo sapeva), dove verrà indicato come sufficiente il fatto che l’associazione “abbia comunque partecipato alla negoziazione” di un contratto applicato nell’azienda: torneremo su questa sentenza nel paragrafo che segue. Questa correzione, però, non modificherà l’impianto della disposizione legislativa: essa si limiterà ad allargare un poco la “porta unica” d’accesso alla titolarità del diritto originariamente prevista nella lettera b dell’art. 19.
- Il revirement contenuto nella sentenza n. 156/2025 rispetto alle sentenze n. 1/1994 e n. 244/1996
Ora invece l’ultima sentenza della Corte interviene a modificare assai più incisivamente la disciplina della materia affermando, in sostanza, che l’aver sottoscritto un contratto collettivo applicato nell’azienda (o l’aver partecipato alla sua negoziazione) non può costituire il requisito indispensabile per l’accesso alla titolarità dei diritti di cui al titolo III dello Statuto: è costituzionalmente necessario ripristinare una seconda porta, che consenta l’accesso a quei diritti anche ad associazioni sindacali che non abbiano né firmato né in alcun modo negoziato un contratto applicato nell’azienda, ma che possano purtuttavia essere considerate apprezzabilmente rappresentative sul piano nazionale. Nel paragrafo che segue propongo alcune osservazioni critiche circa il modo in cui la Corte delinea – in via sussidiaria e provvisoria – il contenuto di questa sorta di rediviva “lettera a” dell’art. 19 adattata al nuovo contesto (v. in proposito § 4); ma è evidente come questo intervento segni un revirement rispetto alle sentenze n. 1/1994 e n. 244/1996: se trent’anni fa la Corte avesse interpretato e applicato il principio costituzionale della libertà sindacale come lo interpreta e applica ora con quest’ultima sentenza, il quesito referendario volto a lasciare in vita il solo criterio della firma di un contratto applicato nell’azienda non sarebbe stato ammesso, stante la (oggi affermata) incostituzionalità del risultato dell’abrogazione proposta.
Come abbiamo già osservato, la decisione non è fondata sul diritto di libertà sindacale sancito nel primo comma dell’art. 39, che deve essere riconosciuto a tutti ed è garantito dal Titolo II dello Statuto. La Corte motiva invece la decisione su di un principio di ragionevolezza cui deve ottemperare il criterio in base al quale l’ordinamento statuale seleziona il sindacato meritevole del particolare sostegno di cui al Titolo III; e, rovesciando l’affermazione contenuta nella propria sentenza del 1996, stabilisce che è irragionevole applicare per questa selezione il criterio sulla base del quale funziona l’ordinamento intersindacale, ovvero quello del riconoscimento reciproco tra le parti. La Corte osserva in proposito che “l’ammissione di un’associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, è condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale”, la quale può persino spingersi a presentare alla controparte sindacale sgradita una “piattaforma inaccettabile e non negoziabile”, se non addirittura a rifiutare l’apertura di trattative con qualsiasi associazione, così ottenendo il risultato di impedire a tutte – o comunque a quelle sgradite – di radicarsi in azienda.
 Sta di fatto, però, che la coincidenza tra titolarità del sostegno statuale e “riconoscimento” nel sistema intersindacale è in tutto e per tutto la conseguenza della vittoria del “sì” su uno dei quesiti referendari del 1995, a seguito della valutazione positiva circa la costituzionalità della conseguenza medesima dichiarata dalla Corte l’anno precedente e confermata due anni dopo. Esito che per un intero trentennio ha inciso in modo molto profondo sul sistema italiano delle relazioni industriali; sulla scia di quel giudizio di costituzionalità del 1994, poi ribadito nel 1996, per un intero trentennio in un gran numero di casi sono state respinte come “manifestamente infondate” le questioni di costituzionalità sollevate da varie parti circa la disciplina della materia risultante dalla modifica referendaria: v. per esempio l’ordinanza della Corte, est. Massimo Vari, del 26 marzo 1998 n. 76 (in NGL, 1998, p. 521), oppure, per la giurisprudenza di merito, tra i primi e per tutti P. Milano 13 novembre 1995 e 18 dicembre 1995 (rispettivamente in q. Riv., 1996, II, p. 24, e in OGL, 1986, p. 829).
Sta di fatto, però, che la coincidenza tra titolarità del sostegno statuale e “riconoscimento” nel sistema intersindacale è in tutto e per tutto la conseguenza della vittoria del “sì” su uno dei quesiti referendari del 1995, a seguito della valutazione positiva circa la costituzionalità della conseguenza medesima dichiarata dalla Corte l’anno precedente e confermata due anni dopo. Esito che per un intero trentennio ha inciso in modo molto profondo sul sistema italiano delle relazioni industriali; sulla scia di quel giudizio di costituzionalità del 1994, poi ribadito nel 1996, per un intero trentennio in un gran numero di casi sono state respinte come “manifestamente infondate” le questioni di costituzionalità sollevate da varie parti circa la disciplina della materia risultante dalla modifica referendaria: v. per esempio l’ordinanza della Corte, est. Massimo Vari, del 26 marzo 1998 n. 76 (in NGL, 1998, p. 521), oppure, per la giurisprudenza di merito, tra i primi e per tutti P. Milano 13 novembre 1995 e 18 dicembre 1995 (rispettivamente in q. Riv., 1996, II, p. 24, e in OGL, 1986, p. 829).
Vero è che una sorta di preannuncio della svolta odierna nella giurisprudenza costituzionale era ravvisabile in un obiter dictum della sentenza n. 231 del 2013 sopra citata, nel quale la Corte aveva sostanzialmente delineato una sorta di diritto a partecipare alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo in capo al sindacato dotato di ampio consenso tra i lavoratori: nel commento di Raffaele De Luca Tamajo a quella sentenza (in RGL, 2014, I, pp. 47-49) si osserva come in questo modo la rappresentatività necessaria per accedere alle prerogative di cui al Titolo III St. lav. torni a essere “presunta per diffusione del consenso”. Hanno dunque ragione ora Carlo Zoli (La costituzione delle rappresentanze sindacali in azienda ecc., in corso di pubbl. su VTDL, 2025) e Arturo Maresca (nel suo intervento al convegno svoltosi su questo tema alla “Sapienza” di Roma il 14 novembre scorso) quando sottolineano il nesso che lega quella sentenza di dodici anni or sono a quest’ultima. Osservo però che, se in quell’occasione la Corte avesse seguito la linea di ragionamento esposta ora nella sentenza n. 156/2025, essa non si sarebbe limitata ad allargare la “porta unica” prevista dall’art. 19 per consentire il “passaggio” anche a chi avesse partecipato attivamente alla negoziazione di un contratto applicato nell’azienda, ma avrebbe detto chiaro e tondo già allora che a un sindacato di cui sia accertata la maggiore rappresentatività sul piano nazionale, che abbia partecipato o no alle trattative per un contratto applicato nell’azienda, non possono essere negate le prerogative di cui al Titolo III dello Statuto. Che è quanto dire che il referendum del 1995 non avrebbe dovuto essere ammesso.
Se dunque di un vero e proprio revirement si è trattato, colpisce il silenzio in proposito della sentenza che lo ha determinato, nella cui motivazione la svolta non viene messa a fuoco in modo esplicito: la sentenza n. 1/1994 – quella, cioè, che ammise il referendum sull’art. 19 – nella motivazione della sentenza n. 156/2025 non viene nemmeno richiamata. Viene ivi menzionata soltanto, nel § 5.2.1, la sentenza n. 244 /1996, con la quale, in coerenza con quella del 1994, la Corte respinse la questione di costituzionalità sollevata in riferimento al nuovo assetto dell’art. 19; questa, però, viene trattata come se fosse una decisione riguardante direttamente non la disciplina della materia delle rappresentanze sindacali aziendali, bensì l’autonomia negoziale dell’imprenditore, del quale veniva confermata la libertà di scelta della controparte contrattuale. La motivazione prosegue osservando che, dunque, con la sentenza n. 244/1996
la discrezionalità del datore di lavoro privato nella selezione dell’interlocutore negoziale è garantita come manifestazione della libertà del contraente
(primo capoverso del § 5.3.4); senonché – osserva la Corte – in questo modo viene eccessivamente compressa la libertà sindacale:
Nell’interstizio tra la libertà dell’impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo, denunciato dall’odierno rimettente
(terzo capoverso del § 5.3.4). Il punto è che “il vuoto di tutela” qui menzionato, ovvero la chiusura del varco residuo per l’accesso alle prerogative di cui al Titolo III, non era una sorta di “effetto collaterale” della sentenza n. 244/1996 che quella stessa sentenza non avesse considerato, ma era proprio l’oggetto principale di quella decisione, confermativa della precedente del 1994 sulla stessa materia. Ed è proprio su questo punto che si determina ora una drastica svolta della giurisprudenza costituzionale; senonché la svolta non viene evidenziata e, anzi, la motivazione tende a presentarsi come una sorta di completamento del ragionamento contenuto in quella sentenza, quasi in continuità con essa.
Non è in discussione il fatto che anche la giurisprudenza costituzionale possa mutare e persino – come è accaduto in questo caso – far registrare delle vere e proprie conversioni a U; ma deve sempre essere trasparente il motivo che sottende il mutamento. Nella sentenza in esame, invece, questo è mancato: non è dato trovare nella sua motivazione alcun riconoscimento del mutamento stesso; neppure un sintetico accenno a che cosa sia mutato durante il trentennio – nel contesto socio-economico, nei riferimenti culturali principali, o anche soltanto nel modo di intendere la discrezionalità del legislatore ordinario e di definirne i confini – al punto da indurre oggi la Corte a una decisione di segno opposto rispetto a quelle del 1994 e del 1996.
È vero che nelle motivazioni delle sentenze di ciascuna delle Corti superiori si cerca sempre di sottolineare gli aspetti di continuità rispetto alla giurisprudenza precedente della stessa Corte, anche in occasione di mutamenti rilevanti; ma in questo caso, se le osservazioni sopra proposte sono fondate, si è trattato di una vera e propria svolta di 180 gradi, attuata e motivata tuttavia come se si fosse trattato soltanto di un ultimo passo in un lunga sequenza di piccoli progressivi aggiustamenti della disciplina della materia. La realtà, invece, è che il sistema delle relazioni industriali viene sottoposto a una scossa tellurica di alto grado, che ne muta molto incisivamente i connotati.
- Il nuovo varco aperto dalla Corte per l’accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto, e gli interrogativi in proposito
La Corte ritiene dunque che sia costituzionalmente necessario riaprire una “seconda porta” per l’accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto, in aggiunta alla “porta unica” rimasta aperta dal giugno 1995 in poi. E poiché non può fare affidamento su di un tempestivo intervento del legislatore ordinario, provvede essa stessa a delineare il criterio che per ora deve applicarsi. Lo fa ispirandosi al criterio cui la legislazione ordinaria fa diffusamente ricorso per l’individuazione del contratto collettivo applicabile, nei casi di concorso di più contratti in uno stesso settore o azienda: in attesa di una riforma organica della materia della rappresentanza sindacale, dunque, il criterio aggiuntivo e alternativo per l’accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto viene provvisoriamente individuato dalla Corte in quello della “maggiore rappresentatività comparativa” dell’associazione sindacale, rispetto alle altre concorrenti. La nuova norma che, fino a nuovo ordine, disciplina la materia, dettata nel § 9 della motivazione e nel dispositivo della sentenza, è la seguente:
[oltre che nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie, o che abbiano almeno partecipato alla negoziazione, di contratti collettivi applicati nella stessa] le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
È difficile sottrarsi all’i mpressione che l’effetto di questa nuova norma si avvicini molto a una “riapertura” del varco inizialmente costituito dalla lettera a dell’art. 19 St. lav. nella sua versione originaria. È vero che ora viene meno il requisito del carattere “confederale” dell’associazione sindacale nazionale; ma la differenza è davvero esile, se si considera quanto, nell’esperienza di applicazione di quella norma nell’ultimo decennio precedente alla sua abrogazione referendaria, fosse facile acquisire il requisito della “confederalità” mediante l’aggregazione tra sindacati autonomi di varia natura e dimensione (valga per tutti l’esempio della Confsal, nata nel 1979 dalla fusione tra Snals e Unsa proprio al fine di offrire a tutta la galassia del sindacalismo autonomo una sorta di “ombrello” confederale che consentisse di chiedere l’accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto).
mpressione che l’effetto di questa nuova norma si avvicini molto a una “riapertura” del varco inizialmente costituito dalla lettera a dell’art. 19 St. lav. nella sua versione originaria. È vero che ora viene meno il requisito del carattere “confederale” dell’associazione sindacale nazionale; ma la differenza è davvero esile, se si considera quanto, nell’esperienza di applicazione di quella norma nell’ultimo decennio precedente alla sua abrogazione referendaria, fosse facile acquisire il requisito della “confederalità” mediante l’aggregazione tra sindacati autonomi di varia natura e dimensione (valga per tutti l’esempio della Confsal, nata nel 1979 dalla fusione tra Snals e Unsa proprio al fine di offrire a tutta la galassia del sindacalismo autonomo una sorta di “ombrello” confederale che consentisse di chiedere l’accesso alle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto).
La nuova “porta” aperta nell’art. 19 St. lav. dalla sentenza n. 156/2025 produce dunque un effetto pratico molto simile a quello della lettera a originaria: riapre un varco per tutti i sindacati non firmatari di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, imponendo il solo requisito dell’estensione nazionale dell’organizzazione e di una consistenza dimensionale che consenta di considerare soddisfatto il requisito della “maggiore rappresentatività comparativa”.
A quest’ultimo proposito, tuttavia, si pone un problema di non facile soluzione. Come ha puntualmente osservato Marco Marazza in un suo primo commento “a caldo” della nuova sentenza (Rappresentanza sindacale in azienda dopo Corte cost. n. 156/2025, editoriale del sito GC.com, 3 novembre 2025), il criterio della “maggiore rappresentatività comparativa” può logicamente funzionare per selezionare il contratto collettivo applicabile, cioè per individuare l’associazione o la coalizione più rappresentativa in un concorso nel quale il “vincitore” deve essere uno solo; ma la norma contenuta nell’art. 19 St. lav. non ha la funzione di selezionare un unico “vincitore”, bensì soltanto di evitare un’eccessiva proliferazione di rappresentanze sindacali nella stessa unità produttiva, garantendo purtuttavia la possibilità di accesso alle prerogative di cui al Titolo III a una pluralità di associazioni. In altre parole, in questo “concorso” i “vincitori” devono poter essere più di uno, se si vuole che il pluralismo sindacale sia garantito. E allora non è chiaro come, secondo la Corte, il criterio della “maggiore rappresentatività comparativa” dovrebbe funzionare: quali dovrebbero essere i termini della “comparazione”? Forse è sufficiente che l’associazione interessata dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto alla media aritmetica delle altre? Oppure maggiore rispetto alla mediana? Oppure maggiore rispetto alla soglia del cinque per cento stabilita dal Codice della Rappresentanza contenuto nell’accordo interconfederale del 2014, che pure viene menzionato nella motivazione della sentenza n. 156/2025?
La “porta” che davvero si apre per effetto della scelta di questo criterio sembra, non soltanto a me, essere quella di un contenzioso giudiziale tanto più numeroso quanto più incerto è il contenuto pratico della nuova norma dettata in via provvisoria dalla sentenza stessa (in questo senso v., oltre agli scritti citati sopra di B. Caruso, M. Marazza e C. Zoli, anche A. Perulli, Rappresentatività sindacale ecc., Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2025).
- Segue – La “madre di tutte le questioni”, in materia di rappresentatività sindacale: quali sono i confini della “categoria”?
Ancora più difficile, se possibile, da risolvere è un altro interrogativo che si pone in molti casi per l’applicazione della nuova regola posta dalla Corte: come si definisce la categoria o settore nel cui ambito deve essere operata la comparazione?
L’ipotesi che possano essere determinati autoritativamente, per legge o per atto amministrativo, i confini – oggi si preferisce l’espressione “perimetri” – dei settori entro i quali va misurata la rappresentatività delle associazioni tra loro concorrenti evoca un sostanziale ritorno al sistema dell’“inquadramento costitutivo”, già sperimentato nel ventennio corporativo, rispetto al quale l’ordinamento repubblicano, con l’art. 39 Cost., ha inteso voltar pagina in nome del principio della libertà sindacale . Proprio in virtù di questo principio costituzionale il libero gioco delle relazioni industriali ha potuto far sì che i confini tra le categorie si modificassero nel tempo per consentire a nuove categorie di nascere: si pensi a quella dei piloti d’aereo rappresentati dall’Anpac, nata negli anni ’70 per scissione da quella ben più ampia della gente dell’aria rappresentata dai sindacati confederali del settore Trasporti, o a quella della “grande distribuzione”, nata per scissione dall’amplissima categoria del Commercio per effetto del contratto collettivo stipulato nel 2018 da Federdistribuzione con Cgil Cisl e Uil (v. in proposito Mariella Magnani, Riflessioni sulla misurazione della rappresentatività ecc., CSDLE, n.376/2018). Ogni nuova categoria sindacale nasce quasi sempre sulla base della pretesa che il confronto della rappresentatività tra le associazioni venga operato nell’ambito di un’area più ristretta rispetto a quella della più ampia categoria originaria.
In altre parole, è il principio costituzionale stesso della libertà sindacale che impedisce la predeterminazione in sede legislativa o amministrativa dei “perimetri” categoriali entro i quali la comparazione di rappresentatività può e deve essere effettuata (v. sul punto la trattazione più recente e compiuta di R. De Luca Tamajo, Le criticità della rappresentatività sindacale “misurata”: quale perimetro?, in q. Riv., 2020, I, p. 377 ss., partic. § 4: ivi ulteriori riferimenti in proposito). Colpisce che proprio la Corte costituzionale nella sentenza in esame abbia ignorato questo problema: è, a ben vedere, proprio questo l’ostacolo che per quasi ottant’anni ha impedito l’attuazione del meccanismo previsto dall’ultimo comma del medesimo art. 39 per la selezione del contratto collettivo di settore cui attribuire l’efficacia erga omnes; ed è questo stesso l’ostacolo che ha determinato l’insabbiamento di molti progetti di sistemazione della materia del concorso-conflitto tra contratti collettivi, ultimo quello contenuto nel “Patto della Fabbrica” del 2018. In ciò consiste, a ben vedere, la madre di tutte le questioni in materia di attuazione dell’art. 39 e di disciplina della rappresentatività sindacale.
Sta di fatto che, in difetto della necessaria definizione del “perimetro” della categoria sindacale, la norma introdotta nell’ordinamento da quest’ultima sentenza costituzionale additiva potrà “risolvere provvisoriamente” soltanto una parte, probabilmente non la maggiore, dei problemi sul tappeto; non scioglie comunque il nodo che rende assai difficile una riforma legislativa della materia. Ha ragione Bruno Caruso quando nel suo commento sopra citato della sentenza n. 156/2025 osserva:
Il quadro odierno, che affianca la decisione sull’art. 19 alle pronunce più recenti in materia di licenziamento illegittimo, mostra come la supplenza giudiziale abbia raggiunto un punto critico: le soluzioni interpretative non bastano più a garantire certezza, uniformità e prevedibilità.
Possiamo solo sperare che il sistema delle relazioni industriali, riscuotendosi dallo stato letargico in cui versa ormai da un decennio, sappia dare il colpo di reni necessario per un accordo interconfederale cui il legislatore possa fare riferimento per una nuova disciplina organica della materia.
- Auspicabilità, ma non vincolo costituzionale, di una riforma della materia ad opera del legislatore ordinario
La sentenza costituzionale n. 156/2025 presenta dunque innanzitutto un difetto di motivazione, consistente nel non avere in alcun modo esplicitato e tanto meno argomentato la drastica svolta che essa segna rispetto alla giurisprudenza della Corte concretatasi nelle sentenze n. 1/1994 e n. 244/1996, sulla base della quale per trent’anni sono state respinte come manifestamente infondate censure di incostituzionalità della disciplina dell’accesso alle prerogative del Titolo III dello Statuto, che, se presentate oggi, la Corte stessa avrebbe invece accolto (v. sopra, § 3). La stessa sentenza presenta inoltre un difetto non secondario nel contenuto della norma che essa pone per correggere, sia pure soltanto in via provvisoria, l’aspetto di ritenuta incostituzionalità dell’art. 19 St. lav. (v. sopra, §§ 4-5). Detto questo, resta da chiedersi se un intervento della Corte su questa materia – magari meglio motivato rispetto all’orientamento precedente della stessa Corte e meglio calibrato nel dispositivo additivo – fosse comunque davvero auspicabile.
 La mia opinione è che una ridefinizione del criterio selettivo per l’accesso al sostegno di cui al Titolo III St. lav. sia, sì, opportuna (nella parte finale di questo intervento propongo qualche nota in proposito); ma che essa non sia costituzionalmente necessaria, perché a) il principio costituzionale della libertà sindacale è compiutamente attuato dalle norme contenute nel Titolo II dello Statuto; e b) in materia di legislazione di sostegno deve essere lasciato al legislatore ordinario lo spazio per una scelta più restrittiva, quale quella risultante dall’abrogazione referendaria del 1995 (sulla cui ragionevolezza quanto scrisse l’estensore Mengoni della sentenza n. 244/1996 mi sembra del tutto condivisibile), e una scelta tendente ad allargare maggiormente il novero dei beneficiari. Il grave difetto di quest’ultimo intervento della Corte consiste nell’avere drasticamente ristretto lo spazio di cui dispone il legislatore ordinario in questa materia. È, a ben vedere, lo stesso risultato che gli interventi della Corte negli ultimi sette anni hanno prodotto nella materia della disciplina dei licenziamenti, dove sono state stigmatizzate come irragionevoli e quindi vietate al legislatore italiano scelte corrispondenti a norme pacificamente in vigore e convalidate dalle Corti costituzionali di numerosi altri Paesi europei e di altri continenti (come – per far solo un esempio – quella che commisura rigidamente l’indennizzo all’anzianità di servizio della persona interessata: cfr. sul punto le osservazioni critiche mosse alla giurisprudenza recente della Corte su questa materia dal costituzionalista A. Morrone, Sui licenziamenti illegittimi. Co-legislazione giurisprudenziale e tutela effimera del diritto al lavoro, LDE, n. 4/2024). Vedo il rischio che nella materia del diritto del lavoro la supplenza della Corte costituzionale finisca col diventare essa stessa un fattore determinante dell’inerzia di un legislatore ordinario la cui discrezionalità viene indebitamente compressa, e che questa inerzia a sua volta finisca coll’incoraggiare e incrementare il ruolo di supplenza della Corte, in un circolo vizioso dal quale la nostra materia ha poco da guadagnare e molto da perdere.
La mia opinione è che una ridefinizione del criterio selettivo per l’accesso al sostegno di cui al Titolo III St. lav. sia, sì, opportuna (nella parte finale di questo intervento propongo qualche nota in proposito); ma che essa non sia costituzionalmente necessaria, perché a) il principio costituzionale della libertà sindacale è compiutamente attuato dalle norme contenute nel Titolo II dello Statuto; e b) in materia di legislazione di sostegno deve essere lasciato al legislatore ordinario lo spazio per una scelta più restrittiva, quale quella risultante dall’abrogazione referendaria del 1995 (sulla cui ragionevolezza quanto scrisse l’estensore Mengoni della sentenza n. 244/1996 mi sembra del tutto condivisibile), e una scelta tendente ad allargare maggiormente il novero dei beneficiari. Il grave difetto di quest’ultimo intervento della Corte consiste nell’avere drasticamente ristretto lo spazio di cui dispone il legislatore ordinario in questa materia. È, a ben vedere, lo stesso risultato che gli interventi della Corte negli ultimi sette anni hanno prodotto nella materia della disciplina dei licenziamenti, dove sono state stigmatizzate come irragionevoli e quindi vietate al legislatore italiano scelte corrispondenti a norme pacificamente in vigore e convalidate dalle Corti costituzionali di numerosi altri Paesi europei e di altri continenti (come – per far solo un esempio – quella che commisura rigidamente l’indennizzo all’anzianità di servizio della persona interessata: cfr. sul punto le osservazioni critiche mosse alla giurisprudenza recente della Corte su questa materia dal costituzionalista A. Morrone, Sui licenziamenti illegittimi. Co-legislazione giurisprudenziale e tutela effimera del diritto al lavoro, LDE, n. 4/2024). Vedo il rischio che nella materia del diritto del lavoro la supplenza della Corte costituzionale finisca col diventare essa stessa un fattore determinante dell’inerzia di un legislatore ordinario la cui discrezionalità viene indebitamente compressa, e che questa inerzia a sua volta finisca coll’incoraggiare e incrementare il ruolo di supplenza della Corte, in un circolo vizioso dal quale la nostra materia ha poco da guadagnare e molto da perdere.
- Una riforma possibile
Per finire, qualche appunto sulla riforma che sarebbe a mio avviso auspicabile, purché emanata dal Parlamento e non dal Giudice delle leggi.
Le questioni di costituzionalità che si pongono per qualsiasi intervento legislativo in questa materia sono due: una è quella, discussa sopra (§ 5), del contrasto che si determina tra qualsiasi predeterminazione rigida dei confini della “categoria” e il principio di libertà sindacale sancito dal primo comma dell’art. 39 Cost.; l’altra riguarda al tempo stesso il meccanismo istituzionale mediante il quale al contratto collettivo nazionale o territoriale può essere conferita l’efficacia erga omnes e il dato quantitativo su cui deve basarsi la misurazione della rappresentatività di ciascun sindacato, poiché nell’ultimo comma dell’art. 39 è definito sia il meccanismo (una sorta di “Camera delle Corporazioni” democratizzata), sia il criterio di misurazione, riferito esclusivamente al numero degli associati.

Federico Mancini
Se si considera tuttora attuale e condivisibile, su questo tema, il messaggio contenuto nella notissima prolusione bolognese di Federico Mancini (RTDPC, 1963, p. 570 ss.), deve convenirsi che la soluzione più lineare passa attraverso una riscrittura dell’ultimo comma dell’art. 39 Cost., che riservi alla legge ordinaria la disciplina della materia senza imporle altro vincolo se non quello derivante dal principio generale di libertà e di democrazia sindacale. Una mini-riforma costituzionale come questa ben potrebbe essere politicamente agevolata da un accordo interconfederale che la sollecitasse al Parlamento, al tempo stesso delineando il contenuto di una riforma della materia che possa essere varata subito dopo con una legge ordinaria.
Quanto al contenuto di quest’ultima, un progetto che ha il pregio della grande semplicità è quello proposto nello scritto già citato di Raffaele De Luca Tamajo pubblicato su questa Rivista nel 2020 (§ 7): esso prevede che la rappresentatività delle associazioni sindacali concorrenti venga misurata entro due soli “perimetri”: quello aziendale, ai fini dell’accesso alle prerogative del Titolo III dello Statuto, e quello nazionale per la selezione del contratto collettivo nazionale applicabile erga omnes. Soluzione che comporterebbe di fatto il ritorno a una presunzione di maggiore rappresentatività del sindacato aderente ai sindacati confederali maggiori, rilevante però soltanto per la selezione del contratto collettivo con efficacia erga omnes: il godimento del “sostegno” in seno all’azienda sarebbe infatti dimensionato esclusivamente in proporzione al dato elettorale, oppure alla media tra dato elettorale e dato associativo, come previsto dal Codice della rappresentanza del 2014.
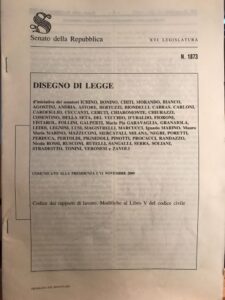 Un’altra soluzione possibile è quella delineata nel c.d. Codice del lavoro semplificato, proposto da un folto gruppo di senatori nella XVI legislatura (d.d.l. n. 1872/2009) e riproposto nella XVII (d.d.l. n. 986/2013; il testo si può leggere nel mio libro Il lavoro ritrovato, Mondadori, 2015). Il progetto è sintetizzabile come segue: a) i rappresentanti sindacali aziendali sono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti da ciascun sindacato in una consultazione elettorale; b) la rappresentatività delle associazioni sindacali concorrenti, in funzione della selezione del contratto collettivo applicabile, si misura nell’ambito del campo di applicazione definito dal contratto stesso; c) nel caso in cui il campo di applicazione di un contratto sia minore rispetto a quello di un altro contratto concorrente, il confronto si opera all’interno dell’area minore, sulla base della somma dei risultati elettorali conseguiti dai sindacati concorrenti nelle aziende comprese nell’area stessa. Si osservi come questa regola sia sostanzialmente coerente con quella contenuta nell’accordo interconfederale del giugno 2011 che prevede la derogabilità del contratto collettivo nazionale o territoriale da parte del contratto aziendale stipulato dalla coalizione sindacale comparativamente più rappresentativa. L’obiezione che a questa soluzione muove l’Autore del primo progetto testé citato (§§ 5 e 6 del suo scritto, dove si paventa il rischio di un dimensionamento opportunistico del campo di applicazione del contratto collettivo) è, a mio avviso, superabile; ma i limiti di spazio di questo intervento impongono di rinviare ad altra sede la discussione in proposito.
Un’altra soluzione possibile è quella delineata nel c.d. Codice del lavoro semplificato, proposto da un folto gruppo di senatori nella XVI legislatura (d.d.l. n. 1872/2009) e riproposto nella XVII (d.d.l. n. 986/2013; il testo si può leggere nel mio libro Il lavoro ritrovato, Mondadori, 2015). Il progetto è sintetizzabile come segue: a) i rappresentanti sindacali aziendali sono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti da ciascun sindacato in una consultazione elettorale; b) la rappresentatività delle associazioni sindacali concorrenti, in funzione della selezione del contratto collettivo applicabile, si misura nell’ambito del campo di applicazione definito dal contratto stesso; c) nel caso in cui il campo di applicazione di un contratto sia minore rispetto a quello di un altro contratto concorrente, il confronto si opera all’interno dell’area minore, sulla base della somma dei risultati elettorali conseguiti dai sindacati concorrenti nelle aziende comprese nell’area stessa. Si osservi come questa regola sia sostanzialmente coerente con quella contenuta nell’accordo interconfederale del giugno 2011 che prevede la derogabilità del contratto collettivo nazionale o territoriale da parte del contratto aziendale stipulato dalla coalizione sindacale comparativamente più rappresentativa. L’obiezione che a questa soluzione muove l’Autore del primo progetto testé citato (§§ 5 e 6 del suo scritto, dove si paventa il rischio di un dimensionamento opportunistico del campo di applicazione del contratto collettivo) è, a mio avviso, superabile; ma i limiti di spazio di questo intervento impongono di rinviare ad altra sede la discussione in proposito.
IL MUTAMENTO DI ROTTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI RAPPRESENTANZA SINDACALE IN AZIENDA – Riassunto. Il saggio evidenzia come la sentenza n. 156/2025 della Consulta sull’art. 19 St. lav. segni una svolta netta rispetto all’orientamento espresso nelle sentenze degli anni ’90, che è statto applicato dai giudici per trent’anni: mentre quelle avevano riconosciuto la legittimità costituzionale della norma che allineava perfettamente il criterio per l’accesso alla legislazione di sostegno al criterio del riconoscimento reciproco tra le parti proprio dell’ordinamento intersindacale, ora questa scelta legislativa viene dichiarata irragionevole. L’Autore ritiene che questa svolta non sia adeguatamente motivata nella sentenza; ritiene inoltre che essa limiti in modo eccessivo lo spazio di discrezionalità che al legislatore ordinario deve essere lasciato in questa materia. Il saggio critica altresì, sul piano tecnico, la norma che la Corte ha introdotto nell’ordinamento in via provvisoria, evidenziandone le difficoltà di applicazione; e – auspicando un intervento del Parlamento sulla materia, delinea due possibili soluzioni.
THE CONSTITUTIONAL COURT’S CHANGE OF WAY ON UNION REPRESENTATION IN COMPANIES – Summary. The essay stresses that the Italian Constitutional Court’s ruling no. 156/2025 on Article 19 of the Statute n. 300/1970 marks a clear turning point compared to the approach expressed in its rulings of the 1990s, which was applied by ordinary Courts for thirty years. Those rulings recognized the consistency with the Constitution of that rule, amended by the popular referendum of 1995, which perfectly aligned the criterion for unions’ access to supporting legislation with the criterion of mutual recognition between the parties: the criterion on which the inter-union system is founded; this legislative choice is now declared unreasonable. The Author sustains that this turning point is inadequately argued in the ruling no. 156/2025; furthermore, he believes that it excessively limits the discretion that ordinary legislator should be allowed in this matter. The essay also criticizes, on a technical level, the provision that the Constitutional Court provisionally introduced into the legal system, highlighting the difficulties in applying it; and — hoping for Parliament’s intervention in this matter — outlines two possible solutions.
